 Com’è noto, la pubblica Amministrazione ‘parla’ mediante atti che assumono le forme più varie – dall’ordinanza al decreto, dalla concessione all’autorizzazione, dalla delibera alla determina – ma che sono tutte espressione della volontà di un soggetto costituzionalmente ‘superiore’ (l’Amministrazione) nei confronti di un destinatario costituzionalmente ‘inferiore’ (l’amministrato). La volontà dell’ente, trasfusa nell’atto, può promanare da organi collegiali (Consiglio dei ministri, giunta comunale, ecc.), da soggetti singoli eletti o nominati (sindaco, ministro, ecc.) e da funzionari, cioè da persone che hanno un rapporto organico con l’ente il quale per l’appunto esplicita la sua volontà mediante la parola – meglio, la penna o la tastiera del computer – dei suoi impiegati.
Com’è noto, la pubblica Amministrazione ‘parla’ mediante atti che assumono le forme più varie – dall’ordinanza al decreto, dalla concessione all’autorizzazione, dalla delibera alla determina – ma che sono tutte espressione della volontà di un soggetto costituzionalmente ‘superiore’ (l’Amministrazione) nei confronti di un destinatario costituzionalmente ‘inferiore’ (l’amministrato). La volontà dell’ente, trasfusa nell’atto, può promanare da organi collegiali (Consiglio dei ministri, giunta comunale, ecc.), da soggetti singoli eletti o nominati (sindaco, ministro, ecc.) e da funzionari, cioè da persone che hanno un rapporto organico con l’ente il quale per l’appunto esplicita la sua volontà mediante la parola – meglio, la penna o la tastiera del computer – dei suoi impiegati.
In Italia il rapporto ente pubblico-utente è stato sempre difficile e improntato alla reciproca sfiducia, di cui una responsabilità non piccola è da attribuire al ‘burocratese’, cioé l’uso da parte dei pubblici funzionari di quel linguaggio specialistico, contorto e poco comprensibile che tutti conosciamo.
Il ricorso al ‘burocratese’ è un vezzo che risale molto indietro nel tempo. Già nel 1830 veniva pubblicato un Manuale per migliorare lo stile di cancelleria, di Giuseppe Dembsher, il quale invitava gli impiegati ad adottare uno stile chiaro e conciso, evitando vocaboli ambigui, usando periodi brevi e astenendosi dall’uso di vocaboli stranieri quando non fossero assolutamente necessari. Evidentemente molti sono rimasti sordi a tale invito, se a quello sono seguiti molti altri manuali e guide.
La cosa più ridicola è che la stessa pubblica Amministrazione è conscia dell’astrusità del proprio linguaggio, tant’è che, per esempio, la Camera di commercio di Milano si è sentita in dovere di pubblicare un apposito dizionario del linguaggio burocratico. Per non parlare del Fisco (quello della «lettera codiciata», della «nota attergata» e dello «sportello impresenziato») che, al culmine di un rimorso di coscienza, ha pubblicato Il linguaggio del Fisco. Dizionario pratico dei termini tributari, dove con involontario umorismo spiega che lo scopo del dizionario è di «decifrare» i termini tecnici rendendoli comprensibili. Che fossero difficili lo sapevamo, ma che fossero ‘cifrati’… !
Ma cominciamo dalle cose più semplici: i nonsensi lessicali. Capita spesso che, per un senso (sbagliato) di rispetto, la normativa della pubblica Amministrazione – la quale per sua natura deve imporre obblighi o stabilire divieti – venga tradotta in un linguaggio che ne ‘depotenzia’ la forza ingiuntiva, quasi un tentativo di conferire all’ente che li emana una disposizione amichevole: «Si prega voler provvedere nel termine perentorio di…». È una preghiera o è un ordine? «Al fine di valutare l’accoglibilità… è opportuno che…». Ma è opportuno o è obbligatorio?
Qualche volta viene attenuata la valenza di un termine ritenuto troppo ‘forte’. Così lo spazzino è diventato netturbino e, successivamente, ‘operatore ecologico’; il cieco è ora ‘non vedente’ e il sordo ‘non udente’. Ma esiste anche il ‘non docente’. Insomma, una qualifica discende dalla negazione di un’altra, cosicché qualcuno per spiegare ‘chi è’, nel senso di che mestiere fa, deve dire ‘quello che non è’! Sempre meglio, comunque, della qualifica di lavoratori ‘co.co.co.’ (collaborazione coordinata continuativa): manco fossero galline in un pollaio!
Ma uno dei neologismi più singolari partorito da mente umana è ‘articolista’. Una volta questo termine designava l’autore di articoli, cioé il giornalista. Oggi, invece, indica colui che, in Sicilia, svolge lavori ‘socialmente utili’ – questa la dizione ufficiale (ma, viene da chiedersi, esistono lavori ‘socialmente inutili’?). Dunque, sono costoro giornalisti? Manco per sogno. E allora perché ‘articolisti’? Perché lavorano in forza dell’articolo 12 della legge regionale 12 dicembe1995 n. 85. Penso che più o meno tutti gli impiegati lavorino in forza di un articolo di legge… Ma, attenzione! Questi ‘articolisti’ non vanno confusi con i ‘cinquantunisti’ che sono quelli che lavorano 51 giorni, né con i ‘centounisti’ che lavorano 101 giorni. Epperò esistono anche i ‘centocinquantunisti’. Che diavolo facciano non importa a nessuno, contano solo i giorni: 51, 101, 151. Ma, poi, perché mai quell’uno finale? Sorge il sospetto che serva a fare superare rispettivamente i 50, i 100 e i 150 giorni al fine di ottenere un qualche beneficio.
Accanto alle difficoltà lessicali, non è difficile rinvenire nelle pubbliche Amministrazioni tutta una serie di ostacoli che a volta sembrano fatti apposta per farci arrabbiare. Prendiamo ad esempio l’autocertificazione. Le resistenze all’applicazione delle varie leggi in materia (per inciso: perché ce ne devono essere tante?) sono note a tutti. A chi si presenta a uno sportello per ‘dichiarare’ un certo fatto senza esibire un pezzo di carta col timbro di un ufficio, gli impiegati sollevano mille difficoltà esibendo un’aria scettica e manifestando il loro sentimento di sfiducia nei confronti del dichiarante.
E sapete che il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consente di ‘autocertificare’ l’esistenza in vita? Autocertifico, dunque esisto!
Sempre a proposito di autocertificazione, molti enti pubblici hanno predisposto dei moduli allo scopo di facilitare la dichiarazione. In questi moduli ricorre l’espressione «dichiaro sotto la mia personale responsabilità». Ma cosa mai significa questa frase? Se ne può fare a meno? Il solerte impiegato vi dirà di no, ma a ben pensarci, si potrebbe mai rendere una dichiarazione sotto la responsabilità – mettiamo il caso – di mio cognato o del mio vicino di casa? Evidentemente è una sciocchezza, della quale però nessun burocrate che si rispetti (si fa per dire) farebbe a meno.
Così come chi rilascia un certificato non si sognerebbe mai di omettere che esso viene rilasciato «per gli usi ove convenga». Certo, sarebbe sconveniente rilasciarne uno ‘per gli usi sconvenienti’, ma nessuno si è mai posto il problema. Il verbo ‘convenire’ nella sua forma intransitiva impersonale ha il significato di ‘essere necessario’, per cui la frase va così tradotta: ‘per gli usi necessari’. Ed è evidente che se la cosa non fosse necessaria per un certo uso, nessuno la chiederebbe. In ultima analisi: non significa niente! A volte si usa un’altra formula altrettanto idiota: il certificato viene rilasciato «per gli usi di legge». Vi siete mai chiesti cosa voglia dire? E siccome qualche impiegato ha pensato che non voglia dire proprio nulla, ecco che ha modificato la formula in «per gli usi consentiti dalla legge». E questa in effetti ha un significato inequivoco, per cui chiunque voglia usarli per compiere qualche truffa, per coerenza ne dovrà chiede uno ‘per gli usi vietati dalla legge’.
Se l’impiegato, ma anche chiunque altro, riflettesse sul significato delle parole, molti cartelli sparirebbero. Come quelli (e sono tantissimi) che, ai trasgressori di un divieto, minacciano punizioni «ai sensi della normativa vigente». Cosa vuol dire? Che per essi si applicheranno le leggi attuali e non quelle del Regno delle due Sicilie? O che qualche autorità ha in teoria la facoltà di emettere punizioni anche al di fuori della legge, ma che nel caso specifico (bontà sua) si limiterà ad applicare le sanzioni previste dalle leggi che sono in vigore? O non è solo una forma di linguaggio stupidamente burocratico?
Una volta c’erano i film ‘vietati ai minori’. In italiano è vietato tutto ciò che non è permesso, per cui non vi sono alternative: o una cosa è consentita o è vietata. Eppure vi erano anche i film «assolutamente vietati». Ma se una cosa non è consentita (e perciò vietata) ogni sua trasgressione viola un precetto, quindi la categoria dei film ‘assolutamente’ vietati non dovrebbe esistere. È evidente che il superlativo assoluto aveva il solo scopo di informare lo spettatore che le scene erano superlativamente erotiche. Dunque aveva un valore meramente propagandistico.
Eppure ancora oggi è facile leggere negli uffici «È severamente vietato fumare», il che vuol dire che in quei locali in cui è ‘semplicemente’ vietato fumare una tiratina alla sigaretta la si può dare. O no? Ma se è no, qualcuno dovrebbe spiegare il significato dell’avverbio ‘severamente’. In verità è a tutti noto che in Germania è vietato tutto ciò che non è permesso, in America è permesso tutto ciò che non è vietato, in Iran è vietato anche quello che è permesso e in Italia è permesso anche quello che è vietato. Capita l’antifona?
A volte, nel tentativo di rafforzare un concetto, si cade nel ridicolo. Se vi è un termine di presentazione di una domanda è sufficiente dire «entro il…» oppure «non oltre il…». Le due espressioni sono perfettamente identiche. E allora che senso ha scrivere in taluni atti «entro e non oltre il…»? È chiaro che se è ‘entro’ non può essere ‘oltre’!
Anche i notai cadono in questo tranello. È vero che «quod abundat non vitiat» (sed rompet!), ma scrivere che viene venduto un bene «con area libera… sovrastante» non vi sembra troppo? E quando mai un immobile ha un’area sottostante? Si regge in piedi per virtù dello Spirito Santo? E quando si vende qualcosa «tutto incluso» non è sufficiente fermarsi lì, o per forza dobbiamo aggiungere anche «nulla escluso»? Forse che il concetto non è abbastanza chiaro? E negli atti di donazione perché il notaio scrive «che con animo grato accetta»? Come fa a dire che l’animo, di per sé imperscrutabile, del donatario è grato? Ma cosa vi potete aspettare da uno che «accende le ipoteche»?
Alzi la mano chi non ha dovuto presentare in vita sua un certificato di sana e robusta costituzione. Sul fatto che un aspirante al pubblico impiego debba avere una costituzione sana è cosa sacrosanta, se non altro per evitare che le sue frequenti assenze per malattia provochino disguidi e danni all’amministrazione. Ma perché ‘robusta’? Certo, per chi aspira a fare il vigile del fuoco o il corazziere non c’è nulla da obiettare; ma se uno volesse fare, per esempio, l’attuario (colui che è addetto alla compilazione delle statistiche) perché mai la sua costituzione, oltre che sana, dovrebbe essere anche ‘robusta’, come richiesto dall’art. 11 del concorso pubblico bandito il 24 ottobre 2001? Forse che deve caricarsi sulle spalle pesanti faldoni di percentuali? Oppure un mingherlino che si occupa di statistiche non può che essere un idiota? Altre volte è l’ottusità a farla da padrone. Da una decina d’anni la patente di guida non è più una autorizzazione discrezionale concessa dal prefetto, ma un semplice documento che attesta l’idoneità tecnica a guidare veicoli. Come tale, il rilascio non spetta più alla Prefettura (che da qualche di tempo si chiama Ufficio del Governo, e che per almeno altri cinquant’anni continueremo a chiamare come prima) ma a un organo puramente tecnico quale la motorizzazione civile (che da qualche tempo si chiama Dipartimento dei Trasporti Terrestri, e che per almeno altri cinquant’anni continueremo a chiamare come prima). Avete notato come spesso si cambiano i nomi ma le cose rimangono immutate? Per esempio, con la legge Bassanini Decr. Leg. 30 luglio 1999 n. 300) il Ministro guardasigilli è divenuto Ministro della Giustizia, perdendo la ‘Grazia’, ma noi continueremo sempre a chiamarlo Ministro di Grazia e Giustizia. E non solo noi, gente comune. Continuano a farlo anche i massimi dirigenti di quello stesso Ministero (e di altri) che, evidentemente, ignorano la ‘novità’, o non ritengono grave la perdita della ‘grazia’, come attestano le seguenti circolari: 14 gennaio 2009 n. 4 sul conguaglio dei contributi previdenziali, 30 giugno 2005 n. 85 sempre in materia contributiva, 5 gennaio 2006 n. 3 in materia di riduzione del costo di lavoro, 19 ottobre 2005 n. 113 in materia di vittime del terrorismo, e così via.
Ma torniamo alla nostra patente di guida. È stato a lungo oggetto di pareri discordanti se la patente, oltre a consentire la guida di un veicolo, potesse essere utilizzata come documento di riconoscimento. In realtà il problema non avebbe neanche dovuto essere posto dal momento che il regolamento del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) all’art. 292 afferma che sono equipollenti – termine altisonante che significa semplicemente ‘equivalenti’ – alla tessera di riconoscimento «tutti i documenti rilasciati da un’amministrazione statale e muniti di foto». Ora: la nuova patente è munita di foto? Risposta: sì. La Motorizzazione civile è una branca dell’Amministrazione statale? Ovvio. E allora perché mai la patente di guida non dovrebbe valere come documento di riconoscimento? Eppure molti uffici facevano difficoltà ad accettarla, al punto che il Ministero dell’Interno fu costretto a inviare una nota esplicativa ai prefetti. E ancora oggi risulta che qualche impiegato la accetti storcendo il naso o addirittura dichiari di preferire un altro documento d’identità, come se ciò fosse lasciato alla sua scelta discrezionale.
A volte non ci sarebbe motivo di complicare le cose, ma ogni ente che si rispetti ha un suo U.C.A.S. (ufficio complicazioni affari semplici) per rendere difficile la vita al cittadino. Anche nel linguaggio. Se è vero che ‘parlare chiaro è segno di amicizia’, allora il dr. Vincenzo Lissa, segretario generale del comune di Ariano Irpino, è da considerare il nemico pubblico numero uno. Come fa a essere «meridianamente epifanica l’indifferenza contenutistica»? si chiedeva Gian Antonio Stella nel settembre del 2010 sul «Corriere della Sera» commutando un’espressione contenuta nella Circolare n. 15547 inviata dal dr. Listra ai dipendenti comunali. Per cercare di capirci qualcosa, il fine giornalista di Via Solferino andò a intervistare il solerte funzionario, il quale gli spiegò che c’era «un’aporia» e che «da entrambe le parti vi era un fondamento assiologico legittimo», frase che il giornalista si affrettò a tradurre «nel senso che tutti e due avevano ragione». Non ritenne invece di ‘tradurre’ l’ulteriore giustificazione che ne diede il dr. Lissa: «Questo opera la crasi operativa perfetta tra norma ed azione,giacché si onora quel paradigma scolpito a forti tinte nella carta costituzionale. Come ammoniva Calamandrei, teoria e pratica sono due facce della stessa medaglia, disparatamente insofferenti ad ogni forma di scissione logico-sistematica». Chiaro no? Alla fine il povero Stella, prima ferito da un «in sede professionale faccio appello a un sano realismo del burocratese giuridico» e poi definitivamente massacrato dal «realismo giuridico e il diritto come astrazione da investire acriticamente, affondandolo in una palude decisamente nomostatica», si arrese. Una mitragliata di burocratese militante a cui avrebbe forse potuto sopravvivere se avesse opposto, a titolo di legittima difesa, la «palingenetica obliterazione dell’io trascendentale che si infutura nell’archetipo prototipo dell’antropomorfismo universale».




















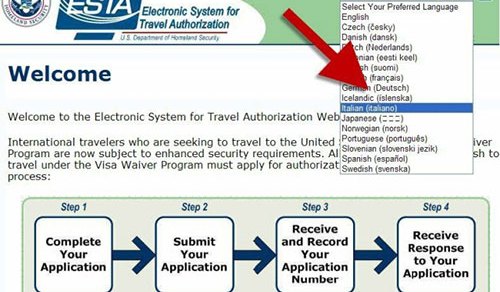
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento