Alla fine le motivazioni sono arrivate: hanno spiazzato i non pochi che si erano quasi rassegnati ad aspettare il 14 gennaio o il giorno dopo, ma non hanno colto di sorpresa i costituzionalisti. Perché, in fondo, molte delle riflessioni fatte “a comunicato caldo”, dopo che la Corte costituzionale (il 4 dicembre scorso) aveva reso nota la sua decisione sui punti nevralgici della legge elettorale, si sono rivelate corrette. La sentenza che fa calare il sipario sul Porcellum, a conti fatti, si presenta piuttosto chiara e coerente, anche se in alcuni punti lascia inevitabilmente perplessi.
Prima di sapere perché la Consulta aveva dichiarato parzialmente incostituzionale l’ultima versione delle leggi elettorali per le Camere, gli studiosi volevano capire perché la Corte avesse “deciso di decidere”, senza defilarsi più o meno elegantemente come aveva fatto in altri casi in cui si discuteva delle regole per trasformare i voti in seggi. In particolare, nelle valutazioni sulla rilevanza, si voleva comprendere su che base il giudice delle leggi avesse ritenuto «concretamente ed effettivamente instaurato» il giudizio a quo, «con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere».
Ora, per la Consulta il giudizio principale avrebbe il fine di «accertare la portata del proprio diritto di voto, resa incerta da una normativa elettorale in ipotesi incostituzionale». Questo, a detta dei giudici, permetterebbe di dire che la eventuale sentenza (di accoglimento) non coinciderebbe in toto con le pretese di chi aveva instaurato il giudizio a quo: intraprendere un’azione dichiarativa per far accertare i “confini” del proprio diritto di voto avrebbe un fine più ampio rispetto all’accertamento della legittimità costituzionale delle norme elettorali che traducono in concreto quello stesso diritto.
Chi scrive non crede che il giudizio principale non sia stato instaurato solo per attivare la Consulta: il sospetto che questa avrebbe potuto pronunciare l’inammissibilità resta, per la difficoltà di dare effetti concreti all’accertamento della lesione del diritto di voto nel giudizio a quo («la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto» come ulteriore oggetto di quel giudizio pare poca cosa).
La Corte ha però ritenuto prevalente l’esigenza di pronunciarsi sul diritto di voto (per la sua «peculiarità» e il «rilievo costituzionale»), aggiungendo che «[l]’esigenza di garantire il principio di costituzionalità rende […] imprescindibile affermare il sindacato» della Consulta stessa: ha pesato – ed è comprensibile – la difficoltà di sottoporre in altro modo a giudizio di legittimità le norme elettorali nazionali (per il regime di verifica dei poteri previsto), che «definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo». Tra il rispetto di un principio – l’inammissibilità di lites fictae – posto dalla stessa Corte e la necessità di evitare «zone franche» nella giustizia costituzionale per non arrecare (nel delicato campo elettorale) «un vulnus intollerabile per l’ordinamento costituzionale», il giudice delle leggi ha preferito la seconda ipotesi.
Passando alle questioni di legittimità, è in linea con le previsioni dei giuristi e gli interventi precedenti della Consulta la decisione sul premio di maggioranza: è stato riconosciuto illegittimo per la mancanza di una soglia minima da raggiungere, assenza «tale da trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea».
A prima vista si può concordare: le ultime elezioni hanno mostrato che a fare la differenza sono stati pochi voti (cosa accaduta pure nel 2006), voti che hanno premiato una coalizione il cui partito più forte (il Pd) ha ottenuto meno voti del M5S, che ha pagato la scelta di “correre” da solo. Lo si può vedere come una distorsione irragionevole e (dunque) inaccettabile, specie considerando che, in base all’art. 67 Cost., le Camere sono «sedi esclusive della “rappresentanza politica nazionale”» e – ricorda la sentenza – a loro sono affidate per questo «funzioni fondamentali, dotate di “una caratterizzazione tipica ed infungibile”». È la stessa Corte a dire che queste funzioni (soprattutto la revisione costituzionale) pongono il Parlamento su un piano diverso rispetto alle «altre assemblee rappresentative di enti territoriali».
Qualche riflessione, però, va fatta. Correttamente la Corte ricostruisce il cammino delle disposizioni costituzionali sul voto: il favore per un sistema proporzionale non era stato tradotto in previsioni della Carta e tocca(va) al legislatore la discrezionalità nella scelta del sistema da questi ritenuto «più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico». Il Porcellum però non supera lo «scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza», che impone di verificare se il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti abbia compresso troppo uno di essi, valutando la proporzionalità dei mezzi usati dal legislatore rispetto ai fini da perseguire. Per la Consulta sono scopi legittimi la stabilità di governo e la rapidità della decisione mediante la formazione di «un’adeguata maggioranza parlamentare», ma c’è stato un ribaltamento della «ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005».
Dunque, accanto all’eccessiva compressione della rappresentatività parlamentare, riconosce anche un’alterazione tanto dell’uguaglianza del voto ex art. 48, comma 2 Cost., quanto della formula elettorale adottata: in questo si appoggia anche alla giurisprudenza straniera, secondo la quale da un sistema anche solo parzialmente proporzionale gli elettori si attendono «che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto».
Quest’osservazione, però, convince solo in parte. È da vedere, infatti, che il sistema introdotto con la legge n. 270/2005 sia un proporzionale corretto. Casomai, sarebbe più corretto definirlo come maggioritario, a ripartizione proporzionale (è la tesi di attenti studiosi dei sistemi elettorali, su tutti di Antonio Agosta): il premio sarebbe l’inevitabile conseguenza di considerare l’Italia (esclusa la Valle d’Aosta) come un unico collegio, in cui – come in tutti i sistemi a formula maggioritaria – chi prevale anche solo per un voto “vince”.
Si può non essere d’accordo sull’impostazione, ma in questo modo diventa meno giustificato (se non addirittura inopportuno) il rilievo della Corte sul ribaltamento del sistema proporzionale, mentre restano corrette le considerazioni fatte sulla peculiare rappresentatività che dovrebbero avere le Camere. Lo stesso discorso, però, a questo punto si potrebbe applicare anche alle altre leggi elettorali: si pensi a quelle che non prevedono un turno di ballottaggio, a partire da quella per le elezioni nei comuni sotto i 15mila abitanti. Anche in quel caso, alla lista che ottiene anche solo un voto in più (e, magari, con una cifra elettorale bassa, qualora concorrano varie liste) viene data la maggioranza assoluta dei seggi che, visti i numeri sempre più stretti delle assemblee elettive, va ben oltre il 51%. L’ultima riduzione del numero dei consiglieri comunali ha mostrato quanto sia compressa oggi la rappresentatività delle minoranze, pure se non esigue: anche quella legge dev’essere rivista, alla luce della sentenza n. 1/2014?
Quanto al premio previsto per il Senato, la sentenza punta il dito anche contro l’inidoneità agli scopi predetti di questo strumento, per la sua configurazione regionale. Essa può comportare che «la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea».
Il pensiero è corretto (e se n’è avuta la dimostrazione due volte), ma si impongono due riflessioni: la prima – piuttosto amara – fa ricordare che a chiedere la “regionalizzazione” del premio al Senato, non prevista nel primo “progetto Calderoli”, era stato il Quirinale, sul presupposto che un premio nazionale anche al Senato sarebbe stato incostituzionale per il mancato rispetto dell’art. 57, comma 1 («Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale»). La seconda porta a richiamare le parole di Temistocle Martines (maestro, tra l’altro, dell’attuale presidente della Corte, Gaetano Silvestri), secondo il quale la norma sulla base regionale del Senato era «generica, ambigua, polivalente», frutto di «un compromesso malriuscito ed a fatica raggiunto all’Assemblea costituente»: un premio nazionale sarebbe stato rispettoso di quella proposizione? E, nel caso, sarebbe bastato prevedere circoscrizioni regionali per osservare quella norma o le strade da seguire sarebbero state altre?
Per chiudere sul premio di maggioranza, non si può non vedere che la Corte, alla “bocciatura” di quello strumento, non fa seguire la caducazione consequenziale di altri congegni, a partire da quello più strettamente legato al premio: quello delle coalizioni. Restano in piedi la facoltà di coalizzarsi (con obbligo di condividere programmi e l’indicazione del “capo”) e – soprattutto – il sistema di soglie di sbarramento privilegiate, che alla Camera consentono l’accesso alla ripartizione dei seggi a tutte le forze che superino il 2% (non il 4% valido per chi corre da solo) e, addirittura, delle “migliori perdenti” in ogni coalizione (nelle elezioni del 2013 sono state addirittura tre). Si può leggere questo “lacerto” come la volontà di indurre comunque una “polarizzazione” del sistema, ma a questo punto si avrebbe il risultato assurdo per cui ai partiti più piccoli conviene coalizzarsi, ai partiti grandi no (sperando di spartirsi più seggi, con meno soggetti candidati alla distribuzione).
La seconda questione riguarda le liste bloccate: dopo la diffusione del comunicato, il dubbio maggiore per gli esperti riguardava i “limiti” di questa illegittimità costituzionale, se la Corte avesse ritenuto incostituzionali tutte le liste bloccate o solo quelle del Porcellum, per i loro caratteri peculiari. Alla fine, si è rivelata corretta la seconda risposta. La Consulta, infatti, ha notato che la libertà di voto dell’elettore è compromessa dal fatto che «il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo […] di candidati, che difficilmente conosce», un elenco il cui ordine – determinante per l’elezione – è deciso dai partiti. La lunghezza, dunque, è stata individuata come il problema di queste liste bloccate, che concorrono all’individuazione della quasi totalità dei seggi delle due Camere. Volutamente la Corte segnala che il contesto cambia del tutto qualora le liste bloccate riguardino solo una parte dei seggi – come avveniva col Mattarellum – oppure le circoscrizioni elettorali siano «di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto» (come accade nel sistema “spagnolo”): in questo modo, di fatto, la Consulta interviene anche nel dibattito delle ultime settimane, sulle possibili opzioni per il nuovo sistema elettorale.
Per il giudice delle leggi, la dichiarazione di incostituzionalità delle liste bloccate vale «nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati». A differenza di quanto avevo sostenuto a dicembre, non si tratta di una sentenza additiva di principio (soluzione forse preferibile) ma di un’additiva tout court: la Corte ha precisato che sono solo «apparenti inconvenienti» che non incidono sulla funzionalità del sistema elettorale “di risulta” la previsione dell’elezione secondo l’ordine di lista (non essendo incompatibile con la preferenza) e, soprattutto, la mancata previsione dello spazio per la preferenza sulla scheda attualmente rimasta in vigore, di cui avevo fatto cenno proprio nel mio intervento di dicembre.
La legge elettorale “di risulta”, dunque, sarebbe già applicabile, come si conviene per leggi costituzionalmente necessarie come quelle elettorali. È la stessa Corte, peraltro, a dire che a rimuovere gli inconvenienti potranno provvedere anche «normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia» (segno che qualche ritocco è già immaginato) e lo dice anche a proposito dell’interpretazione della preferenza come indicazione di un solo candidato: è curioso, però come la Consulta indichi a sostegno di quest’ipotesi il risultato del referendum del 1991, mentre il sistema che risulta dalla sentenza n. 1/2014 è lontanissimo da quello delineato (per il Senato) dalla consultazione del 1993.
Anche qui, due ulteriori osservazioni servono. Per cominciare, spiace che la Corte si sia limitata a citare, come causa di limitazione della libertà del voto, «la possibilità di candidature multiple e [la] facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito»: è proprio la possibilità di multicandidature ad avere prodotto le distorsioni peggiori del voto dei cittadini (non per colpa della norma, ma per l’abuso abnorme fatto dai partiti) e si sarebbe potuto cogliere l’occasione per dichiararne l’illegittimità o per stigmatizzare di più la pratica.
Secondariamente, è stata sprecata anche l’occasione di dire che il sistema delle liste bloccate sarebbe stato accettabile qualora, finalmente, i partiti avessero accettato di “darsi regole”, attraverso una legge sulla democrazia interna che manca dal 1947 e attui in pieno l’art. 49 Cost.: in altre parole, chiedere alle Camere di imporre ai partiti (o di indurli) a darsi regole precise – tra l’altro – sulla selezione delle candidature, magari attraverso una forma di elezioni primarie, sarebbe stata molto apprezzato.
In conclusione, il sistema elettorale, così come conformato dalla Consulta, somiglia moltissimo a quello con cui si è votato nel 1992, con una formula proporzionale a preferenza unica (ma allora non c’erano coalizioni e relative soglie di sbarramento). Sarà anche autoapplicativo, ma da lì a ritenere che possa effettivamente funzionare (e per di più “bene”), la distanza è parecchia. E – altra cosa certa – il sistema così sembra non piacere proprio a nessuno, lasciando tutti insoddisfatti: di fatto, dunque, la pronuncia allunga (anche solo di qualche settimana o mese) la vita al Parlamento e al governo tuttora in carica.
Perché per la Corte è chiaro – lo sottolinea nell’ultima parte della sentenza – che le Camere uscite dalle ultime elezioni figlie del Porcellum hanno comunque pieno titolo per proseguire nella loro azione. Sulla delegittimazione politica di quelle assemblee non ci sono dubbi, anche se i giudici della Consulta non ne parlano (non spetta a loro occuparsene); su quella giuridica, invece, la Corte utilmente ricorda che la sentenza «produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale», mentre restano validi e vigenti gli «atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto». Anche la mancata convalida di vari parlamentari, dunque, non è vista come un vulnus in questo senso.
Depongono a favore di questa ricostruzione tanto la considerazione che le sentenze non spiegano effetto sui rapporti “esauriti” (e il procedimento elettorale, pur lungo e articolato, si è concluso da tempo con la proclamazione degli eletti), quanto il principio fondamentale della «continuità dello Stato», attraverso la continuità degli organi costituzionali (lo dimostrerebbe, per dire, la stessa prorogatio dei poteri delle Camere uscenti anche dopo che si sono tenute le nuove elezioni, fino alla proclamazione dei nuovi eletti e alla prima riunione delle nuove assemblee). Un’osservazione che non fa una grinza: se si tornerà a votare in tempi brevi o brevissimi, sarà perché il Capo dello Stato ha deciso di sciogliere il Parlamento (magari su richiesta delle stesse forze politiche) e non perché la sentenza le abbia di colpo fatte diventare abusive o fuorilegge.




















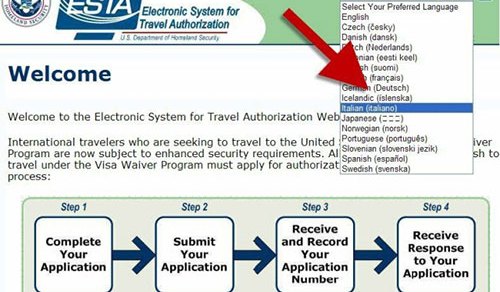
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento