Certamente e doverosamente sono in programma numerose iniziative per ricordare uno degli episodi più drammatici della nostra storia recente; nei prossimi giorni la ricorrenza sarà al centro dell’attenzione.
Sono stati spesi fiumi di inchiostro sulla storia del magistrato Falcone ed esistono approfondimenti molto più autorevoli cui fare riferimento. Mi limito pertanto a brevi considerazioni.
Alcune riflessioni dello stesso Falcone lasciavano intendere da tempo l’esito finale ed inevitabile della sua storia di servitore dello Stato.
“Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande”.
“Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno”.
“In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere”.
“Ci troviamo di fronte a menti raffinatissime che tentano di orientare certe azioni della mafia. Esistono punti di collegamento tra i vertici di Cosa nostra e centri occulti di potere che hanno altri interessi”.
I nomi di Falcone e di Borsellino, dopo la loro morte, sono stati blanditi da molti e talvolta finalizzati allo scopo ed alla convenienza del momento.
E sono blanditi anche da coloro che non hanno esitato a contrastarli in vita.
Celebre e paridgmatico di tale uso italico è il dibattito fazioso seguito all’altrettanto celebre riflessione di Leonardo Sciascia sui “Professionisti dell’antimafia” apparsa sul Corriere della Sera del 10 gennaio 1987.
Dalla articolata tesi di Sciascia secondo cui in Sicilia il modo migliore per fare carriera in politica e in magistratura è dichiararsi antimafioso, usare l’”antimafia come strumento di potere”, come mezzo per diventare potenti ed intoccabili, ne derivò un attacco senza precedenti, delegittimante, a Falcone e Borsellino, a tutto il pool antimafia di Palermo, ai magistrati attivi contro cosa nostra, e ai movimenti antimafia.
Probabilmente Sciascia voleva solo mettere in guardia contro il pericolo che qualche magistrato o politico disonesto potesse sfruttare la lotta alla mafia per i suoi interessi personali.
E’ accaduto però che citare Borsellino come “esempio attuale ed effettuale” di professionismo mafioso, insinuare il dubbio che il magistrato avesse fatto carriera grazie alla lotta alla mafia, è stato sfruttato abilmente dai nemici del pool.
Come spesso accade, tanti “sciasciani” di allora divennero “falconiani” poco più di cinque anni dopo.
Ancora oggi, a vent’anni di distanza, la bagarre non si è quietata. Si fa a gara a collocarsi da una parte o dall’altra. Volano le accuse di “tradimento”; i commenti più o meno interessati reinterpretano, con il senno di oggi, le vicende di allora cercando di individuare buoni e cattivi.
Credo che non sia il modo migliore di onorare la memoria di tutte le vittime della mafia: servitori dello Stato, imprenditori, semplici cittadini, morti perché non si sono sottomessi, costretti a chiudere la propria attività, a lasciare la propria terra…
E certamente non lo è se la polemica alimenta o cerca di influenzare anche il confronto politico-elettorale come purtroppo sta accadendo in questi giorni che vedono la concomitanza delle elezioni amministrative di Palermo e le celebrazioni in memoria delle vittime delle stragi del 1992.
La verità è che non è e non sarà la retorica antimafiosa e sconfiggere la mafia.
Ne abbiamo sentita troppa in questi anni e ne sentiremo altrettanta nel corso delle celebrazioni.
Richiamando le parole del presidente della Repubblica, va ribadito che “per sconfiggere la mafia e la criminalità in Sicilia e nel Mezzogiorno, conta la qualità della politica, il prestigio delle istituzioni democratiche, l’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Conta la crescita della coscienza civica e della fiducia nello Stato di diritto: fiducia che costituisce un vero e proprio capitale sociale e che può rafforzarsi solo in un clima di rispetto, in ogni circostanza, degli equilibri costituzionali da parte di tutti coloro che sono chiamati ad osservarli”.
Ma bisogna tornare con la memoria al 1992; sembra davvero un secolo fa.
All’epoca ero giovane cronista del maggiore quotidiano catanese e vivevo con ansia, con passione, gli eventi tragici che martoriavano la mia terra, dagli episodi più eclatanti ai terribili fatti di cronaca di ogni giorno che impegnavano giornalmente quei tanti, spesso “anonimi”, operatori dell’informazione, i “corrispondenti locali”, forti soltanto delle loro idee e del loro impegno, spesso soli e non garantiti neanche dalla stessa redazione per cui operavano.
Allora come oggi.
Era il 31 gennaio 1992, quando con la sentenza della Corte d’Assise d’Appello vennero confermate le condanne impartite a tutti i principali boss di Cosa Nostra dal maxi processo alla mafia siciliana, così decretando la validità delle accuse mosse dai giudici Falcone e Borsellino, del teorema Buscetta, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che i giudici simbolo della lotta antimafia avevano convinto a raccontare.
A meno di due mesi da quelle sentenze, il 12 marzo 1992, alle ore 9 e 20, all’uscita della sua villa di Mondello, venne ucciso il potente esponente della Dc, Salvo Lima, freddato da alcuni sicari inviati dal cosiddetto “capo dei capi”, Totò Riina.
Era un segnale plateale.
La mafia, duramente segnata dal giudizio dei tribunali, cercava la vendetta agli avversari e alla zona grigia che aveva promesso di difenderla.
Ricordo quando, diffusa la notizia, si ebbe subito la consapevolezza di una svolta storica, ma anche il terribile presentimento che era saltato definitivamente l’equilibrio, il rapporto con una certa parte deviata delle Istituzioni.
Il presentimento dell’inizio di una stagione di sangue.
Qualcuno aveva letto nell’omicidio Lima una sorta di “liberazione”; la fine di una classe politica collusa; addirittura, paradossalmente ed in modo evidentemente inaccettabile – ma bisogna contestualizzare il periodo storico – da un omicidio l’avvio di una rinascita.
Ma la mafia aveva dichiarato guerra agli uomini dello Stato come Falcone e Borsellino, che si erano spesi con tutte le loro forze, per minare alle basi dell’organizzazione mafiosa, e ai referenti politici che alla mafia avrebbero dovuto garantire appoggi e affari.
Il 12 marzo 1992 la mafia uscì allo scoperto.
Lo aveva fatto tante altre drammatiche volte, con Carlo Alberto Dalla Chiesa, Pio La Torre ed altre vittime.
Ma stavolta l’assassinio dava il via ad una vera e propria sequenza di crimini via via più spietati.
Dai colpi di pistola si passò al tritolo, poi alle bombe piazzate nei più prestigiosi luoghi di interesse artistico e culturale del Paese (come agli Uffizi, nel ’93), infine alla preparazione di attentati in prossimità di luoghi affollatissimi allo scopo di causare la morte di centinaia di agenti delle forze dell’ordine e gente comune (come allo Stadio Olimpico, nel gennaio 1994 fortunatamente fallito).
In una fase di transizione e di incertezza del Paese, con un sistema politico e partitico prossimo al collasso sotto i colpi dell’inchiesta Tangentopoli che fece emergere la corruzione dilagante, la mafia rispondeva parlando con il linguaggio a lei più congeniale: la violenza e la morte.
Ma la reazione della gente è stata un fatto imprevedibile e straordinario.
Dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio del 1992, è cresciuta l’indignazione e la partecipazione alle manifestazioni raggiunse le punte più alte; le “donne del digiuno” occuparono per qualche mese piazza Politeama; apparvero i lenzuoli ai balconi di Palermo; nacquero varie associazioni.
In quei terribili anni, sull’onda emotiva del terrore suscitato nel Paese, nacque un moto diffuso e spontaneo di ribellione alla cultura della morte dei clan mafiosi. Cittadini, associazioni, soggetti collettivi di vario orientamento politico, religioso, ideale presero coscienza del fatto che la lotta alle mafie non poteva essere risolta solo sul versante della mera repressione. Non era più possibile delegare ad altri — magistrati e forze dell’ordine — l’impegno nel contrastare il proliferare delle organizzazioni mafiose nel nostro Paese.
Si poteva e si doveva fare molto di più in ambito educativo, nell’animazione democratica del territorio, per coinvolgere i cittadini nell’affermazione della legalità quotidiana, nella realizzazione di quei principi costituzionali che sono l’unico vero antidoto alla cultura mafiosa e all’impresa illegale.
E’ fondamentale alimentare questa “spinta dal basso”, questa consapevolezza.
Ebbe vita la “stagione dei Sindaci”.
Nel 1993, la legge sull’elezione diretta li rese artefici della stagione seguente alla caduta della Prima Repubblica.
Interpreti della domanda di autonomia del territorio e della società, capaci di compensare il crollo di legittimità dello Stato e del sistema politica presso i cittadini, ridiedero fiducia ai cittadini verso le Istituzioni.
Vent’anni dopo, come ha recentemente scritto Ilvo Diamanti, però, i Sindaci si ritrovano soli. Perlopiù sopportati – quanto poco “supportati” – dai partiti. Che li hanno sempre considerati un ostacolo alle proprie logiche oligarchiche e centraliste.
Dagli anni Novanta in poi, hanno rivendicato e ottenuto competenze e responsabilità. Ma dispongono di risorse scarse e di poteri inadeguati.
Il governo tecnico, legittimato – e spinto – dall’emergenza e dai mercati, non finge neppure di valorizzare il ruolo delle autonomie locali e dei sindaci. Ai quali viene, invece, chiesto di trasformarsi da “attori” a “esattori”. Ammortizzatori del dissenso. Addetti a riscuotere tasse impopolari – e a ricucire il rapporto con la società – per conto terzi.
Con l’esito di vedersi delegittimati: dallo Stato e dai cittadini.
La crisi della politica, dei partiti, la sfiducia nelle Istituzioni, la crisi economica, purtroppo, possono diventare terreno fertile, ancora, per le organizzazioni criminali.
Come vent’anni fa.
Ecco perché il ricordo, la memoria non possono restare fine a se stessi.
Per tanto, troppo tempo, analisi sociologiche più o meno coinvolte, hanno “giustificato” la presenza delle organizzazioni mafiose: in un contesto caratterizzato dall’insicurezza, prodotta dal vuoto o dalla carenza delle istituzioni, la mafia offrirebbe la sua “protezione”, chiedendo il pagamento di un prezzo, sotto forma di “pizzo”.
Affermazioni di questo tipo avallano quel “pensiero” che è la forza e l’essenza stessa della mafia, quella “mens mafiosa” che è il cancro che colpisce il nostro territorio.
Quel pensiero che vuole fare passare l’organizzazione criminale come una struttura che “protegge” i cittadini, che garantisce quella sicurezza e quel lavoro che lo Stato non è in grado di assicurare; un pensiero che “legittima” di ricorrere alla sua protezione per rivendicare un diritto, per avere un lavoro, per ottenere ciò che sarebbe normalmente dovuto.
Uno Stato parallelo cui riconoscersi ed affiliarsi.
La realtà è invece ben diversa: la mafia non interviene in una società insicura ma induce insicurezza con le sue minacce e si astiene dal concretare le minacce solo se si sottostà ai suoi soprusi.
Solo uno Stato presente ed una società solidale possono sconfiggere la paura e quindi la mafia.
“Che cos’è questo affidarsi alla mafia se non una ricerca di ordine. E dunque di Stato?”, diceva Falcone, per poi aggiungere: “L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa!”.
E Paolo Borsellino: “E’ normale che esista la paura, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. No lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti”.
Perché le mafie seminano paura e morte: con il traffico di droga, con il racket, i rifiuti tossici, l’usura e il riciclaggio.
E il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, intervistato da Giorgio Bocca, affermava: “Gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi certamente pagati dai cittadini non sono altro che i loro elementari diritti. Togliamo potere alla mafia. Assicuriamo noi alla gente i diritti che chiede alla mafia. Facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati”.
Ricorre il 3 settembre prossimo il trentennale del suo assassinio.
A trenta anni di distanza il suo pensiero è e resta di palese attualità.
Un grande lavoro di divulgazione è effettuato negli ultimi anni da numerose associazioni; Centro Siciliano di Documentazione “Giuseppe Impastato” ha messo a disposizione numerose e approfondite analisi.
Il contesto relazionale entro cui i gruppi mafiosi agiscono è intessuto di rapporti di parentela, di amicizia, cointeressenza, contiguità, complicità e dà vita a un blocco sociale che attraversa la società nel suo complesso.
Diversamente dalla criminalità comune, la mafia non viola il diritto ma nega il diritto: essa è fuori e contro lo Stato, poiché non riconosce il monopolio statale della forza e considera il ricorso all’omicidio come la sua forma di giustizia; ma per le sue attività legate all’uso del denaro pubblico e la sua partecipazione attiva alla vita pubblica, essa è dentro e con lo Stato.
La mafia si insinua e condiziona la politica in vari modi: con l’uso politico della violenza, con il contributo alla formazione delle rappresentanze istituzionali (raccolta e controllo dei voti, partecipazione diretta o mediata alle competizioni elettorali), con il controllo sulle istituzioni in vari modi.
La politica a sua volta può favorire la mafia nel senso che contribuisce al suo sviluppo assicurando l’impunità, consentendo attività in collegamento con le istituzioni e con l’erogazione di denaro pubblico, o attraverso l’istituzionalizzazione di metodi mafiosi.
“La mafia – affermava Falcone – non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano. Vive in perfetta simbiosi con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e piccoli maestri cantori, gente intimidita o ricattata che appartiene a tutti gli strati della società. Questo è il terreno di coltura di Cosa Nostra con tutto quello che comporta di implicazioni dirette o indirette, consapevoli o no, volontarie o obbligate, che spesso godono del consenso della popolazione”.
“Il pericolo dell’inquinamento mafioso del voto, afferma il procuratore Grasso, c’è sempre, perché la mafia si pone come intermediaria tra i bisogni dei cittadini e il potere. Il potere che è in mano alla politica locale o nazionale. Quindi la mafia cerca di partecipare al potere e di condizionarlo e di portarlo ai propri fini. Sappiamo che la mafia è un fenomeno criminale ma anche sociale, finanziario ma anche economico e quindi va combattuto in tutti i campi. Con minor bisogno ci sarà anche un minor bisogno della mafia che spesso fa solo promesse”.
Da questa consapevolezza bisogna agire per una lotta efficace e decisiva al fenomeno mafioso; la memoria di Falcone e Borsellino va onorata su queste basi; un elemento fondamentale su tutti: seguire e colpire i patrimoni frutto dell’attività criminosa.
Bisogna prendere atto che, nell’ambito del fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso, il tema della contiguità assume un’importanza di primo piano.
Le associazioni mafiose, infatti, presentano una particolare attitudine ad intrecciare rapporti di cooperazione, sia attiva, sia passiva, con soggetti “esterni”, attraverso la cui collaborazione esse riescono a condizionare a loro favore tutti i settori della vita associata: la politica, l’economia, le istituzioni, le professioni.
Se si vuole davvero sconfiggere la criminalità organizzata i fronti di azione non possono dunque che essere innanzitutto:
1) azioni efficaci per colpire e confiscare i patrimoni frutto dell’attività criminosa, in modo rapido ed efficace;
2) la definizione chiara della fattispecie criminosa di collateralismo mafioso che fornisce oggi linfa vitale alla criminalità consentendo l’infiltrazione in ogni settore della vita pubblica e del contesto sociale.
Non dimentichiamo, infatti, che l’utilizzo di prestanome è prassi consolidata nelle organizzazioni criminali: ben pochi sono i beni intestati ai mafiosi o ai loro parenti diretti.
Spesso vengono costituite posizioni creditorie di comodo per far saltare l’azione delle misure di prevenzione.
Anche su questo aspetto servono modifiche legislative.
Quanti servitori dello Stato sono caduti per questo!
Il primo a riflettere sull’importanza strategica del patrimonio per i mafiosi fu il segretario del pci siciliano Pio La Torre.
La ricerca di soluzioni legislative per contrastare la mafia impegnò La Torre negli ultimi anni della sua vita, a partire dall’impegno nella Commissione parlamentare antimafia; fu infatti ucciso in un agguato il 30 aprile 1982 assieme al compagno di partito Rosario Di Salvo.
Ma fu solo dopo un nuovo terribile agguato, quello che costò la vita al prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa, alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’autista Domenico Russo (3 settembre 1982), che l’iter legislativo riuscì ad arrivare a compimento
La legge che prese il nome da lui e dall’allora ministro dell’Interno Virginio Rognoni ebbe ricadute operative immediate.
Attraverso di essa fu finalmente introdotto nel nostro Codice penale l’articolo 416 bis che sanziona l’associazione mafiosa in quanto tale.
Le nuove possibilità investigative e giudiziarie rese possibili dall’introduzione nel Codice penale dell’art. 416 bis trovarono una prima straordinaria conferma pochi anni dopo con l’istruzione del cosiddetto maxiprocesso alle cosche palermitane.
Un processo che costò il sangue di numerosi servitori dello Stato, spazzati via dalla furia omicida dei boss nel tentativo disperato di fermare il pool antimafia: prima il giudice istruttore Rocco Chinnici, ucciso con un’autobomba sotto casa (29 luglio 1983), poi i funzionari di Polizia Beppe Montana (28 luglio 1985) e Ninni Cassarà e l’agente Roberto Antiochia (6 agosto 1985).
Il testimone venne raccolto da coraggiosi magistrati quali Antonino Caponnetto — trasferitosi da Firenze in Sicilia per prendere il posto di Chinnici alla guida dell’Ufficio istruzione —, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Anch’essi in pericolo di vita, furono costretti a rifugiarsi all’Asinara per terminare la voluminosa ordinanza che inchiodava capi e gregari mafiosi alle proprie responsabilità.
Al maxiprocesso fu applicata per la prima volta la norma sui patrimoni prevista dalla legge «Rognoni-La Torre», che ha introdotto la confisca dei beni per coloro che fossero riconosciuti mafiosi: «Nei confronti del condannato — recita infatti il c. 7 dell’art. 416 bis — è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego»
Dopo le stragi del 1992 si arrivo finalmente alla Legge n. 109/1996 che prevede che i beni immobili confiscati alle cosche potevano rimanere nel patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile oppure, tramite l’Agenzia del Demanio, essere trasferiti ai Comuni per finalità istituzionali o sociali, con la successiva assegnazione in comodato a enti, associazioni del volontariato e della società civile.
Trenta anni fa, prima di essere barbaramente assassinato, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, affermava: “La mafia orami sta nelle maggiori città italiane dove ha fatto grossi investimenti edilizi o commerciali e magari industriali. A me interessa conoscere questa accumulazione primitiva del capitale mafioso, questa fase di riciclaggio del denaro sporco, queste lire rubate. Ma mi interessa ancor di più la rete mafiosa di controllo, che grazie a quelle case, a quelle imprese, a quei commerci magari passati a mani insospettabili, corrette, sta nei punti chiave, assicura i rifugi, procura le vie di riciclaggio, controlla il potere”.
Vent’anni fa Paolo Borsellino scriveva: “La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”.
Afferma oggi il procuratore Grasso: “La lotta alla mafia dovrebbe essere posta tra le priorità di qualsiasi partito al governo, ma spesso purtroppo non è così. Cosa nostra non ha né strategie né colore politico. Nella lotta alla mafia ci vorrebbero corsie preferenziali e voti unanimi. Le strategie per combatterla non dovrebbero avere colore politico; Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra si espandono nelle regioni del Nord, è la linea della palma che avanza, come aveva profetizzato Sciascia. Non siamo abituati a fronteggiare la mafia quando si inabissa e riscopre il dialogo con le istituzioni. Questo è il risultato di un consenso che garantisce vantaggi, favori e preferenze per chi ne rimane coinvolto”.
Trent’anni di storia che hanno cambiato il nostro Paese; che hanno cambiato il mondo.
Non hanno cambiato l’urgenza e l’attualità della lotta a tutte le mafie.
Perché – affermava Giovanni Falcone “La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni”.




















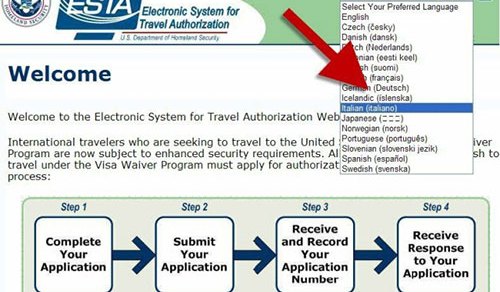
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento