La nota che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha diffuso il 13 luglio, dopo giorni in cui una parte politica ne invocava con insistenza l’intervento, merita di essere analizzata sotto vari profili di diritto costituzionale, che “sfumano” qua e là verso altre branche del diritto pubblico.
La prima riflessione è legata al potere di scioglimento delle Camere: come è noto, esso è stato configurato in più modi dalla dottrina e, di volta in volta, varie interpretazioni sono state proposte dagli inquilini di palazzo Chigi e del Quirinale. Indicando la necessità per le Camere di «procedere con decisione lungo la strada intrapresa» e l’inopportunità di una crisi del governo Letta dopo cento giorni di attività, ma soprattutto etichettando come «arbitrarie e impraticabili» le ipotesi di sciogliere ora le assemblee parlamentari, Napolitano mostra una volta di più – lo aveva già fatto alla fine del 2011, dopo le dimissioni del governo Berlusconi – di non aderire alle ricostruzioni, peraltro minoritarie, che inquadrano lo scioglimento ex art. 88 Cost. come atto sostanzialmente governativo.
Il diniego della disponibilità a sciogliere ora le Camere suggerisce invece l’adesione a una lettura sostanzialmente presidenziale del potere di scioglimento: precedenti dichiarazioni di Napolitano, in cui il potere in questione è definito come «prerogativa propria ed esclusiva del Presidente della Repubblica», confermerebbero l’ipotesi. Su questa base, avrebbe poco spazio anche la ricostruzione dell’atto complesso – per chi scrive, la più convincente – per cui lo scioglimento sarebbe frutto della collaborazione tra il Capo dello Stato e il Presidente del Consiglio o, per lo meno, una parte rilevante delle forze politiche. Pure se varie formazioni presenti nelle Camere si accordassero per far cadere il governo e puntare alle elezioni, non verrebbe meno la posizione di Napolitano sull’impraticabilità dello scioglimento: questi potrebbe anche dover porre fine per forza alla legislatura (per l’impossibilità di formare una nuova maggioranza, il cd. “autoscioglimento”), ma la decisione di sciogliere le Camere, anche qui, sarebbe solo sua. Si assiste dunque a una prevalenza del ruolo presidenziale, come si conviene in una fase di crisi del sistema che ha partorito un “governo di servizio” sostenuto da forze avversarie alle elezioni e, soprattutto, la prima rielezione di un Presidente della Repubblica, eventualità prima sempre esclusa dai precedenti inquilini del Colle (ciò dà più forza all’attuale Capo dello Stato, che ai fini di una più efficace moral suasion potrebbe far pesare le pressioni esercitate su di lui dai partiti per ottenerne la riconferma).
In tema di scioglimento va fatto un ultimo rilievo sulla legge elettorale: la sua revisione è l’unica tra le priorità ad essere citata in dettaglio dalla nota, con l’indicazione di «aspetti più urgenti» da analizzare in fretta e con l’inclusione di tale riforma tra gli indici in grado di «accrescere la fiducia nell’Italia e nella sua capacità di progresso». La riflessione del Presidente sembra riferirsi sia all’intenzione dichiarata (ma non sempre sincera) delle forze politiche di non votare più con il cd. Porcellum, sia al giudizio di legittimità costituzionale che pende sulla legge n. 270/2005 e che, per alcuni, sconsiglierebbe un voto anticipato prima dell’udienza – fissata per il 3 dicembre – in cui la Consulta esaminerà la questione sollevata a maggio dalla Corte di cassazione. Sembra dunque di poter dire che la revisione o il superamento dell’attuale legge elettorale sia, per il Capo dello Stato, condizione necessaria (certo non l’unica) perché si possa pensare allo scioglimento delle Camere.
Il secondo punto da analizzare riguarda l’istituto della grazia ex art. 87, comma 11 Cost. Non serve interrogarsi sulla natura del potere: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200/2006 (che la nota cita) ha risolto un conflitto di attribuzione tra la Presidenza della Repubblica e il Ministro della Giustizia, indicando che il potere di grazia, espressione di una «potestà decisionale del Capo dello Stato quale organo super partes rappresentante dell’unità nazionale» è da considerare formalmente e sostanzialmente presidenziale, avendo la controfirma del Ministro solo il significato di confermare «la completezza e la regolarità dell’istruttoria e del procedimento».
Vale la pena, piuttosto, concentrarsi sulle osservazioni del Presidente. Innanzitutto, va sottolineato il ruolo centrale che – per quanto riguarda il potere in esame – assume il richiamo alla prassi e ai precedenti. Il fatto che l’art. 681 c.p.p., al comma 4, preveda la possibilità di concedere la grazia «anche in assenza di domanda o di proposta» non è considerato sufficiente da Giorgio Napolitano per discostarsi «dalle consuetudini costituzionali nonché dalla prassi seguita in precedenza»: consuetudini e prassi negli ultimi anni – oltre a far riscontrare un netto calo dei provvedimenti di clemenza a partire dalla presidenza Scalfaro, dovuto anche all’entrata in vigore negli anni ’80 di norme sulle misure alternative al carcere – avrebbero fatto ritenere «essenziale» la presentazione della domanda da parte del condannato (o degli altri aventi diritto), anche per non creare una poco accettabile categoria di “condannati più eguali di altri” che abbiano avuto (per ragioni di conoscenza personale o di clamore mediatico) l’attenzione del Capo dello Stato.
Precedenti di grazie concesse in assenza di domanda, a dire il vero, ce ne sono: il sito del Quirinale indica come 5 decreti dei 23 firmati da Napolitano (a fronte di 2461 domande ricevute) non abbiano avuto alcun impulso “formale”. È però probabile che il Presidente avverta l’assoluta delicatezza del caso in questione (specie con riguardo al contesto in cui si colloca) e l’importanza di mantenere intatti il valore umanitario della grazia e il proprio ruolo di organo super partes ricordato dalla Consulta: la scelta di far intraprendere d’ufficio l’istruttoria ministeriale sulla grazia a prescindere da una domanda, quasi “a furor di parte del popolo”, metterebbe a rischio entrambe le cose.
Napolitano poi definisce il vaglio della richiesta come «esame obbiettivo e rigoroso – sulla base dell’istruttoria condotta dal ministro della Giustizia – per verificare se emergano valutazioni e sussistano condizioni» per la concessione della grazia (o della commutazione della pena), il tutto senza mettere minimamente in discussione «la sostanza e la legittimità» della sentenza: ciò, ovviamente, è in linea con i passi della nota relativi alla necessità di prendere atto delle sentenze definitive e, a monte, al «riconoscimento del principio della divisione dei poteri e della funzione essenziale di controllo della legalità che spetta alla magistratura nella sua indipendenza».
Se non è immaginabile che il Presidente della Repubblica ricomprenda se stesso (visto il suo ruolo di “arbitro”) tra coloro che possono manifestare «riserve e dissensi» sulle sentenze, di certo nell’esame della domanda può tenere conto di eventuali ingiustizie palesi che siano state commesse nel processo e non siano state riparate (anche se dovrebbe essere solo un caso di scuola): ciò è conforme all’obiettività dell’esame richiamata da Napolitano. Il rigore comporta invece la verifica di ogni aspetto, anche formale, della domanda: dall’istruttoria del Ministero dovranno emergere vari requisiti, come il carattere definitivo della condanna, nonché elementi di opportunità richiesti dalla prassi e dal carattere umanitario e “premiale” della grazia, compresa l’assenza di altri procedimenti penali in corso, magari segnati da condanne, specie se – come accade nel caso in questione – sono relativi a fatti successivi a quelli alla base della condanna per cui si chiede clemenza.
Per chiudere sulla grazia, se è valido il vecchio brocardo «quod voluit dixit, quod noluit tacuit», bisogna notare come il Presidente – individuando l’oggetto del potere di clemenza – si riferisca esplicitamente alla (sola) «esecuzione della pena principale», la pena detentiva che Napolitano precisa non dover essere scontata in carcere da Berlusconi (per ragioni di età e per la limitata pena residua dopo l’applicazione dell’indulto). Nella nota invece non si fa riferimento alla possibilità di includere nel decreto di grazia anche le pene accessorie, dunque l’interdizione dai pubblici uffici: per l’art. 174, comma 1 c.p. la grazia «non estingue le pene accessorie salvo che il decreto disponga diversamente». Anche qui, la prassi della presidenza Napolitano restituisce episodi in cui l’atto di clemenza ha condonato anche o solo le pene accessorie (rispettivamente due e dieci casi); tuttavia la formula utilizzata nella nota conferma il carattere eccezionale dell’intervento della grazia su quelle pene e non sembra lasciare margini per un’eccezione nel caso specifico che ha generato l’intervento del Colle. Si potrebbe poi notare che nella nota non si parla di pena accessoria perché non è ancora stata rideterminata, cosa che complica la questione: è inopportuno immaginare che si conceda la grazia prima che l’intera condanna sia definitiva, ma l’attesa degli adempimenti mancanti non sarebbe priva di conseguenze per quanto riguarda l’attività politica di Silvio Berlusconi.
L’ultima parte dell’analisi riguarda infatti l’aspetto più discusso della questione: quello ormai noto – con un’espressione coniata da Sandro Bondi – come “agibilità politica” di un esponente di riferimento di un partito o (come in questo caso) di un’intera coalizione che sia condannato in via definitiva. Il Capo dello Stato mostra di avere ben presente la delicatezza della situazione che vede «la condanna a una pena detentiva di personalità che ha guidato il governo […] e che è per di più rimasto leader incontrastato di una formazione politica di innegabile importanza».
Si tratta di una situazione inedita per l’Italia, anche se lo stesso Napolitano ricorda che si era già avuto un episodio di pena detentiva scontata da un ex Presidente del Consiglio, identificato in Arnaldo Forlani, condannato nel 2000 in via definitiva a 2 anni e 4 mesi, scontati con l’affidamento in prova al servizio sociale: va ricordato, tuttavia, che la sentenza di Cassazione per Forlani arrivò 19 anni dopo la fine del suo incarico da Capo del Governo e otto anni dopo le sue dimissioni dalla segreteria della Democrazia cristiana, che aveva guidato sì per sette anni (in tutto), ma senza arrivare mai a una sorta di identificazione con il suo partito. Di più, all’atto della condanna Forlani aveva abbandonato la politica attiva da tempo e non mirava a candidarsi alle nuove elezioni.
Non stupisce che una certa parte politica abbia accolto con favore, oltre che il riconoscimento del “diritto a dissentire” dalla sentenza della Cassazione, la presa d’atto della dimensione politica (e non solo personale) degli effetti della condanna. È naturale, a monte, che il Quirinale abbia considerato le preoccupazioni di quella parte, circa il turbamento del «normale svolgimento, nel prossimo futuro, della dialettica democratica e della competizione politica»: come rappresentante dell’unità nazionale, ex art. 87, comma 1 Cost., è giusto che il Presidente della Repubblica tenga conto di esigenze e preoccupazioni mosse da una parte definita della comunità, perché non nascano o si aggravino fratture o attriti pericolosi per la tenuta del sistema. Per perseguire lo scopo, però, non si può chiedere al Presidente di fare ciò che non gli compete o che le norme non gli consentono.
Ora, la cd. “agibilità politica”, nel caso di specie, sarebbe compromessa sotto vari profili: la possibilità di partecipare alle elezioni sarebbe inficiata dall’interdizione dai pubblici uffici (da rideterminare, dunque non ancora efficace) e dalle nuove norme sull’incandidabilità; a ciò si dovrebbe aggiungere la limitazione dell’attività politica per l’esecuzione della pena detentiva (in qualunque forma sia scontata). Un provvedimento di clemenza del Capo dello Stato – che pure commutasse la pena detentiva in pecuniaria – rimuoverebbe l’ultimo ostacolo, ove il Ministero e il Presidente ravvisassero i requisiti umanitari e di opportunità per emettere l’atto. Per intervenire sulla pena accessoria, invece, il decreto dovrebbe espressamente estendere l’estinzione all’interdizione dai pubblici uffici. Si è visto come le parole di Napolitano sembrino escluderlo, ma non può sfuggire come applicare una norma eccezionale in questo caso rischierebbe di snaturare (come l’avvio d’ufficio dell’istruttoria) tanto il carattere umanitario della grazia, rimarcato dalla stessa Consulta, quanto la posizione super partes del Quirinale: il Presidente si assumerebbe una responsabilità politica forte, che poco si addice a un ruolo come il suo. Va poi esclusa una commutazione della pena accessoria, non prevista (l’art. 174 c.p. parla solo di estinzione): tra l’altro, non pare configurabile una pena “meno grave” in cui commutare l’interdizione, né sarebbe edificante immaginare che una sanzione di quel tipo si possa trasformare in una pena pecuniaria.
Ciò su cui il Capo dello Stato non può invece in alcun modo agire è l’incandidabilità introdotta dalla cd. “legge Severino” (art. 63, legge n. 190/2012 e art. 1, comma 1, lett. c, d.lgs. 235/2012). Questa previsione non è qualificabile come pena principale o accessoria, pertanto il Presidente della Repubblica nulla può fare per impedirne l’applicazione, da parte tanto degli organi parlamentari (sulla valutazione della decadenza), quanto degli uffici elettorali nelle fasi che precedono il voto. Né la concessione della grazia o la commutazione della pena muterebbero la situazione, poiché l’incandidabilità sarebbe conseguenza diretta della sentenza di condanna, che non verrebbe rimossa né (lo si è visto) contestata nella sua legittimità. Dev’essere letto alla luce di questi elementi l’inciso con cui il Presidente invita Berlusconi e il suo partito a «decidere circa l’ulteriore svolgimento – nei modi che risulteranno legittimamente possibili – della funzione di guida finora a lui attribuita».
Scartata ogni ipotesi di intervento diretto del Quirinale in merito (fatta eccezione per un’eventuale moral suasion che il Presidente possa decidere di svolgere sulle forze politiche perché trovino loro una soluzione), la cd. “agibilità politica” potrebbe forse arrivare solo da una soluzione politica, tradotta in norme che affrontino l’iter parlamentare di discussione e approvazione. Non è tuttavia questa la sede per dare un giudizio su questa eventualità, di cui si assumerebbero la responsabilità i partiti che dessero il loro sostegno alle Camere, dando conto della loro azione ai propri elettori.




















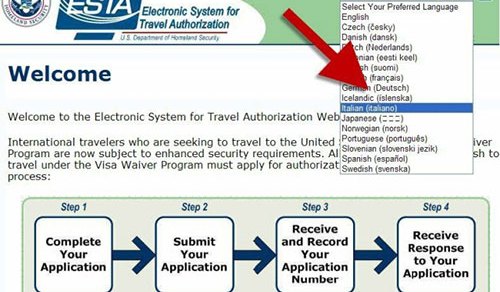
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento