La legge speciale n. 633 del 1941 è nata al fine di salvaguardare il diritto alla paternità e all’integrità dell’opera (opera intesa come creazione immateriale dell’ingegno e che racchiude arti figurative, letteratura, musica, teatro, cinema, etc.), nonché il diritto di pubblicazione ed i consequenziali diritti di riproduzione, esecuzione, rappresentazione, diffusione, distribuzione ed elaborazione dell’opera dell’ingegno.
Orbene, ad occuparsi della gestione e della salvaguardia dell’opera dell’ingegno è un Ente di diritto pubblico (così definito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 1968) che, sostanzialmente, ha il compito di impedire l’indebito utilizzo dell’opera coperta da diritto d’autore e riscuotere i relativi compensi.
Ora, che la SIAE svolga questo compito ad effettiva tutela dell’autore dell’opera oppure in qualità di mero agente di riscossione a favore dello Stato e non dell’artista iscritto, è un argomento tutt’ora aperto e fonte di accesi dibattiti nel settore dell’arte e della cultura. Ad ogni modo è innegabile che l’azione inibente della SIAE sia efficace nei confronti di coloro che intendono utilizzare le opere dell’ingegno altrui a proprio favore.
Ma quid juris per le opere dell’ingegno collettive e non coperte dal diritto d’autore? Insomma, che tutela ha la musica popolare?
Considerando chetali opere rappresentano il genius loci del luogo ove vengono eseguite, occorre interrogarsi sugli strumenti di tutela e di valorizzazione da mettere in campo per impedire il progressivo perdersi della loro memoria.
Prima di affrontare, seppur brevemente, il tema della tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale (di cui la musica ne rappresenta una cospicua parte) occorre porsi una semplice quanto complessa domanda preliminare: perché?
Perché tutelare le musiche insieme ai racconti, canti, proverbi… e tutto ciò che è connesso alla cultura popolare immateriale? Perché l’Ordinamento dovrebbe prendersi la briga di raccogliere questi elementi che forse non rientrano nemmeno nei crismi della culturalità classicamente intesa?
La prima domanda trova la sua risposta nella realtà attuale. Oggi si assiste a continui flussi turistici e all’emersione del c.d. etnoturismo, un fenomeno in forte espansione che sta supplendo altre tipologie di turismo (artistico, termale, balneare, religioso, ecologico); basta fare un giro nei piccoli borghi del Sud Italia, magari d’estate, e notare la continua espansione di offerte turistiche legate ad eventi di cultura popolare, quali concerti, sagre, feste riscoperte o inventate di sana pianta.
E’ anche notoriamente risaputo che l’Italia «è da sempre meta di visitatori attratti non solo dalla presenza di uno o più beni culturali, ma da quel “continuum” che lega strade, edifici, tradizioni culturali, e storia della singola città e dell’Italia intera. Un “continuum” che ha portato alla definizione dell’Italia quale “museo a cielo aperto” e che svolge un ruolo di attrattore forte per il turista culturale, interessato sia a conoscere le città d’arte, e i loro beni culturali, sia il paesaggio, le tradizioni popolari, l’enogastronomia e ogni altra rappresentazione culturale, come i concerti e le esibizioni artistiche».
Orbene, in questo quadro il patrimonio culturale immateriale sta subendo continui attacchi provenienti proprio da coloro che promuovono il marketing territoriale, risaltando i prodotti culturali più piacevoli e vendibili sul mercato turistico e al contempo penalizzando gli aspetti “poco piacevoli” della cultura popolare di riferimento. Penso, per esempio, alla riscoperta, in Salento, della pizzica-pizzica e del simbolo della taranta, un simbolo legato in passato ad un fenomeno peculiare e oggi ormai scomparso: il tarantismo. La taranta, da simbolo mitico-rituale, è divenuto un marchio ormai presente sui souvenirs di tutte le bancarelle della Puglia.
In tale contesto, intere fette di cultura popolare (canti di lavoro, di protesta, nenie funebri, ma anche le tecniche e i saperi che ruotano intorno all’artigianato) si stanno disgregando sotto gli occhi di tutti.
Quando un anziano muore è come se bruciasse una biblioteca. Quando un artigiano appende gli strumenti al chiodo, strozzato dalla concorrenza e dal modello cinese, è come se si dissolvessero nel vento secoli e secoli di conoscenze immateriali.
L’UNESCO, nelle sue Convenzioni, segnatamente la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 e la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005, ha messo in rilievo proprio la necessità di salvaguardare il patrimonio culturale locale in quanto la diversità culturale è essenziale per l’umanità come lo è la biodiversità per la natura, chiedendo ai paesi firmatari di catalogare tutti i beni immateriali presenti sul territorio, senza ulteriori “selezioni per qualità”, proprio al fine di archiviare e rendere fruibile la mole sterminata di beni immateriali, alla stregua di un bene culturale classicamente inteso (appare ovvio che quando si ritrova un pezzo d’anfora questo venga studiato e rinchiuso in un museo. Un pezzo d’anfora non racconta molto né gli si può attribuire valore culturale se non è contestualizzato. Allo stesso modo si dovrebbe raccogliere tutto il patrimonio immateriale senza discernere tra “bello” e “brutto”, tra “orecchiabile” e “noioso”, tra “vendibile” e “non vendibile”).
L’Italia ha aderito ad entrambe le Convenzioni e con il D.Lgs. n. 62/2008 ha effettuato una modifica al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, inserendo l’articolo 7/bis, rubricato “espressioni di identità culturale collettiva”, il quale così dispone: Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10.
Dunque allo stato attuale v’è una normativa che impone di salvaguardare il patrimonio immateriale, sempre che – lo dice la norma – sia ancorato alla materialità e sia corrispondente a quanto stabilito dall’art. 10 del su citato Codice.
Orbene, l‘art. 10, al suo comma 2 stabilisce che le raccolte sono beni culturali ope legis, riconosciuti come tali non all’esito di un procedimento amministrativo di individuazione ma direttamente dalla norma in commento, sulla base del presupposto costituito dalla loro condizione giuridica di raccolte: di insieme di oggetti, cioè, che siano stati acquisiti ed ordinati dagli istituti museali nei modi previsti dal regolamento “per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico” di cui al R.D. 26 agosto 1927, n. 1917.
Dunque, v’è una norma che tutela i beni culturali immateriali, ma dice che possono essere tutelati solo se dotati di materialità e se rispettano i requisiti posti dall’art. 10. Quindi, in altre parole, una serie di registrazioni di canti popolari (ossia una raccolta), effettuate da un antropologo e successivamente catalogate in un archivio o in un museo possono a tutti gli effetti considerarsi un bene culturale e, di riflesso, la tutela spetterebbe anche al canto.
Difatti non è azzardato affermare che nel momento in cui la tutela si applicasse ex lege ad un supporto materiale contenente un elemento immateriale, questa si rifletterebbe sul contenuto del supporto, altrimenti sarebbe come affermare che il Codice dei Beni Culturali tutela un palazzo o una chiesa solo nella loro esteriorità e non per il loro significato storico-identitario o storico-culturale.
A questo punto la domanda sorgerebbe spontanea: come tutelare una musica o un canto popolare senza con ciò congelarli, senza, in altre parole, farli divenire un pezzo da museo? La musica popolare è tale perché si evolve con l’evolversi del contesto in cui è inserita e dunque sarebbe impensabile costringere i suoi esecutori ad eseguirla sempre e comunque nello stesso identico modo.
Qui soccorre una definizione teorica che, se sviluppata, potrebbe favorire la tutela delle musiche e dei canti popolari senza con ciò impedirne l’evoluzione. La definizione riguarda il concetto di tutela riflessa, la quale potrebbe così intendersi:
Attività diretta ad esaminare, mediante le competenze relative alle discipline DemoEtnoAntropologiche, le espressività culturali immateriali “viventi” ed adeguarle, ove occorra, a quelle contenute nei supporti materiali cartacei ed audiovisivi, conservati nei luoghi di cultura della Repubblica, aggiornati costantemente al fine di seguirne l’evoluzione; la tutela riflessa dovrà favorire la diffusione della conoscenza, la preservazione della memoria, nonché, limitatamente al patrimonio culturale immateriale DEA complesso, il rispetto del contesto, della funzione e della struttura propria di ciascun elemento culturale. A tal fine, ove occorra, possono prevedersi discipline e attività che abbiano l’effetto di regolare, limitare, inibire, conformare o anche escludere determinati comportamenti dei soggetti che possano compromettere il valore culturale insito nel patrimonio culturale immateriale.
E’ appena il caso di specificare che il patrimonio culturale immateriale DEA (acronimo di DemoEtnoAntropologico) complesso è quello in cui vi sono più elementi immateriali legati tra loro. Classico esempio è la rota o ronda, ossia il cerchio di suonatori al cui interno si esegue il ballo popolare. Qui vi sono più elementi immateriali: musica, canto, gestualità, balli, tra loro legati.
A conclusione di questo scritto appare utile ribadire la necessità di salvaguardare, da un lato, il vasto patrimonio culturale immateriale di cui ancora disponiamo, prima che si perda nell’oblio della memoria, attraverso la predisposizione di archivi e musei, e dall’altro la musica popolare viva, ancora attiva sul territorio, in modo da favorire esecuzioni musicali consapevoli, nell’ottica di una naturale evoluzione della musica. Del resto, ripetendo le parole di Roberta Tucci, (…) a chi verrebbe in mente di inserirsi, con il proprio strumento musicale o con la propria voce o con il proprio corpo, in un contesto culturale “ufficiale”, quale può essere un concerto (di un’orchestra, di una banda, di un gruppo rock), o uno spettacolo di danza e di teatro? Perché, invece, gli spazi della cultura “popolare” possono venire tranquillamente occupati, senza neanche chiedere il permesso? e perché la musica d’autore è ipertutelata mentre quella popolare può essere liberamente sfruttata, anche a costo di snaturarla, senza che alcuno possa intervenire per proteggerla?




















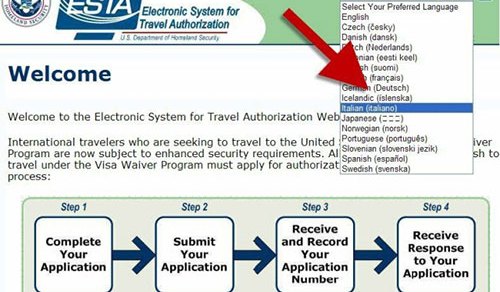
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento