Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Bisogna agire in fretta, si affannano a dichiarare in tanti, esponenti dei maggiori partiti e uomini di governo.
“Se c’è qualcuno che pensa di stare al riparo dall’antipolitica si sbaglia alla grande. Se non la contrastiamo, spazza via tutti”; “C’è bisogno, in maniera vitale, dei partiti politici, non si può indulgere nell’antipolitica. C’è bisogno dei partiti, c’è bisogno di più partiti, di partiti amici della gente e della cultura, che diano idee a questo paese e si chiedano quale sarà l’Italia del 2013”.
E così di seguito.
Affermazioni di principio, tutte condivisibili.
Dall’affermazione di principio, però bisognerebbe passare all’analisi e quindi all’azione.
E bisogna farlo in fretta, con il coraggio e la necessità di rinunciare a posizioni consolidate di potere, di avviare un vero e profondo rinnovamento tangibile, che sappia convincere i cittadini, che non si lasciano più facilmente incantare.
E’ un atto di responsabilità profonda che deve coinvolgere l’intera società civile del nostro Paese: la classe politica in primo luogo, ma anche il sistema economico e sindacale, i responsabili dell’informazione che devono andare oltre la redditizia scelta di cavalcare l’onda del populismo e della demagogia.
Da chi oggi ha la responsabilità di guidare il nostro Paese ed ha il potere ed il dovere di agire in Parlamento è lecito attendersi qualcosa di più che agitare il fantasma dell’antipolitica come rischio grave per la nostra democrazia; occorre andare ben oltre l’ “effetto paura” sull’opinione pubblica e fare in modo, anche con provvedimenti drastici ma efficaci, di recuperare progressivamente fiducia e credibilità, oggi praticamente scomparse.
Vi è un evidente scollamento tra i partiti e la società civile, che crede sempre meno alle promesse e si discosta dall’attività dei partiti, privilegiando forme di democrazia diretta, quali le petizioni e le richieste di referendum su vari argomenti.
L’antipolitica è un pericolo serio, in quanto non è propositiva , distrugge ma non costruisce, la politica.
Qualcuno aveva sperato che Tangentopoli potesse davvero riformare il nostro sistema politico.
Caduta la Prima Repubblica – come convenzionalmente ormai si afferma anche se riteniamo che non si avvenuto alcun cambiamento nell’assetto costituzionale dello Stato tale da segnare il dato storico del passaggio ad una “nuova” Repubblica – in realtà niente è cambiato perché non è cambiato il sistema.
Nella storia, la denominazione di una forma di stato preceduta da aggettivi numerali indica i regimi dello stesso tipo che si sono succeduti discontinuamente in un paese con assetti costituzionali e istituzionali differenti quali ad esempio le Repubbliche.
In Italia la distinzione tra prima e seconda Repubblica è un’espressione giornalistica, divenuta poi di uso comune, ma storicamente scorretta, poiché si riferisce quale elemento di discontinuità storica alla trasformazione politica avvenuta durante il biennio 1992-1994, che non si risolse in un cambiamento di regime bensì in un mutamento del sistema partitico e nel ricambio di parte dei suoi esponenti nazionali.
In ogni caso, malgrado le dichiarazioni di intenti, nulla è cambiato perché nessuno teneva a farlo né aveva la convenienza.
La cosiddetta “seconda Repubblica” si è caratterizzata al contrario per una costante – non so quanto consapevole – demolizione della credibilità delle Istituzioni e contemporaneamente della credibilità della classe politica, anche da parte degli stessi uomini delle Istituzioni.
Un continuo scontro tra i poteri dello Stato, tra Politica e Magistratura, condito da uno stillicidio di inchieste e di comportamenti non certo cristallini ha contribuito a minare dalle fondamenta la credibilità stessa delle Istituzioni agli occhi dei cittadini.
Il grave rischio che oggi si corre è quello che la sfiducia nei partiti e nella classe politica si traduca nella sfiducia nelle Istituzioni.
I cittadini hanno visto più volte tradita la volontà democraticamente espressa.
Le vicende del finanziamento pubblico dei partiti e della legge elettorale sono emblematici; ciò che è avvenuto dopo i referendum del 18 e 19 aprile 1993 appare come un evidente vulnus alla democrazia.
Al quesito: “Volete voi che siano abrogati gli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195: “Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”, così come modificati e integrati: dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11: “Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195”; dall’art. 3, comma 1 e dal comma 6 della legge 18 novembre 1981, n. 659: “Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”?, i cittadini risposero in massa con ben il 90,30%di risposte affermative pari a 31.225.867 votanti (pari a circa il 65,12% del corpo elettorale).
Nonostante il referendum, nel 1996 (Legge 2 gennaio 1997 n. 2) veniva approvata una legge volta a reintrodurre il meccanismo del finanziamento pubblico dei partiti attraverso la possibilità per i contribuenti di devolvere il «quattro per mille» dell’Irpef a questo scopo (peraltro il cittadino disponibile non poteva finanziare il suo partito, ma era costretto a finanziarli tutti e comunque venne stabilito che fosse sufficiente il parere favorevole del 15% dei contribuenti affinché ai partiti fosse assegnato il tetto massimo stabilito dalla legge).
Per poi arrivare alla Legge 3 giugno 1999 n. 157 “Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici” che ha reintrodotto di fatto il finanziamento pubblico”, all’origine degli scandali e delle ruberie da tempo agli onori della cronaca.
E al quesito: “Volete voi che sia abrogata la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante “norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle parti seguenti: art. 17, secondo comma, limitatamente alle parole “al 65 per cento dei votanti”; art. 18, primo comma, limitatamente alle parole “alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario”; art. 19, primo comma, limitatamente alle parole “o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione”; secondo comma, limitatamente alle parole “presentatisi nei collegi”; terzo comma, modificato dall’art. 1 della legge 26 aprile 1967, n. 262, limitatamente alla parola “suddetti”; ultimo comma, limitatamente alla parola “soltanto” nonché alle parole “il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e”?” un percentuale pari all’82,70 (pari a 28 936 747 di votanti) risposero sì.
Tuttavia venne presto approvata una nuova legge elettorale, la cosiddetta “Legge Mattarella” (o “Mattarellum” come sarebbe poi stata ribattezzata dai giornali), la quale prevedeva per l’elezione dei membri della Camera e del Senato un sistema misto con una forte componente maggioritaria (75%) “corretta” da una quota proporzionale (25%), che già in parte vanificava la scelta dei cittadini verso un sistema davvero maggioritario.
Per poi giungere all’attuale legge elettorale, che tradisce completamente la volontà degli elettori.
Nei programmi televisivi si discute della corruzione di deputati e senatori, nelle librerie si accatastano volumi che elencano gli sprechi e le parzialità di qualunque ente conosciuto, dal comune più sperduto al Parlamento: insomma oggi domina la denuncia di tutto, di tutti, per tutto e a tutti i costi.
Chi si azzarda appena a sussurrare che la politica è nobile e necessaria o che il partito è il principale strumento con il quale i senza potere possono organizzarsi e lottare, si espone al pubblico ludibrio.
Eppure, l’attuale situazione è forse un’occasione per ritrovare ricominciare. Tocca alla politica, naturalmente, ai partiti fare il primo passo. Le occasioni non mancano: dalla revisione di tutti i meccanismi del loro finanziamento fino alle sempre promesse riforme elettorale e istituzionali.
E’ un banco di prova che, è evidente, sarebbe suicida fallire.
Non per i partiti e solo per essi – sarebbe un male sopportabile – ma per lo stesso sistema democratico.
Rigenerare la politica è certo più difficile cavalcare l’onda demagogica e populista dell’antipolitica: ma è essenziale e non più rinviabile.
Bisognerebbe sempre partire dalla nostra Carta Costituzionale che all’articolo 49 sancisce: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
I Padri Costituenti avevano ben chiaro il ruolo fondamentale dei partiti, quali libere associazioni dei cittadini allo scopo di concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
Da questa disposizione discendono quattro principi soprattutto:
1. La formazione dei partiti è libera: ogni partito ha diritto di cittadinanza nello Stato italiano qualunque ne sia l’ideologia. L’unico limite a tale libertà, scritto nell’art. XII delle disposizioni transitorie della Costituzione, è la riorganizzazione del partito fascista.
2. La repubblica si fonda sul pluralismo dei partiti. L’uso del plurale (“partiti”) nell’art. 49 della Costituzione implica che sarebbe inammissibile un regime a partito unico. I limiti alla fondazione e all’attività dei partiti possono essere soltanto quelli previsti per le associazioni in generale stabiliti dagli articoli 17 e 18 della Costituzione: le riunioni devono essere pacifiche e senza armi; le finalità associative non devono essere vietate dalla legge penale; sono vietate le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
3. Ai partiti è riconosciuta la funzione di determinare la politica nazionale, in concorrenza tra di loro.
4. I partiti devono rispettare il metodo democratico. L’espressione «metodo democratico» definisce il principio per cui la minoranza deve rispettare le decisioni della maggioranza, ma ha la piena libertà di agire, con tutti i mezzi pacifici a sua disposizione, per diventare a sua volta maggioranza e assumere la guida del paese. È proprio del metodo democratico la possibilità dell’alternanza pacifica al potere tra maggioranza e minoranza.
Dal punto di vista giuridico i partiti politici in Italia sono organizzazioni private che si configurano come associazioni non riconosciute e godono quindi dell’ampia libertà d’azione che è prevista dal codice civile per queste associazioni. Non sono persone giuridiche e pertanto non sono sottoposti ai controlli statali che il codice civile prevede per tali enti.
L’art. 49 della Costituzione è sempre rimasto privo di una necessaria normativa di attuazione, per quanto riguarda l’obbligo che esso impone ad ogni partito di adottare il metodo democratico nella propria organizzazione interna, malgrado sia comunque evidente che sarebbe stato opportuno che la Costituzione stessa o una legge costituzionale o almeno una legge ordinaria successiva, avesse introdotto nel nostro ordinamento alcune norme specifiche allo scopo di garantire l’attuazione del “principio di democrazia interna” mediante apposite disposizioni; soprattutto in materia di controllo della sua adozione mediante apposite norme statutarie da parte dei partiti; di rimedi e di sanzioni per il caso in cui esso venisse violato.
Riprendendo gli atti di un seminario tenuto alla Società Dante di Treviso nel 2003, da un intervento di Giorgio Pizzol, si possono trarre alcuni interessanti spunti di riflessione.
Se il modello costituzionale sopra descritto fosse concretamente attuato e praticato noi ci troveremmo in una situazione tale per cui il libero confronto di idee e iniziative in condizioni di parità fra tutti i cittadini porterebbe realmente ad un “libero concorso” di tutti i cittadini nella formazione delle scelte politiche della Repubblica in tutte le sue diverse articolazioni istituzionali nelle quali si esercitano i tre poteri “sovrani”: legislativo, esecutivo, giudiziario.
Sembra lecito pensare pertanto che un corretto funzionamento di questo “modello” di democrazia, sia in grado di produrre necessariamente una selezione sia dei gruppi dirigenti dei partiti sia dei componenti degli organi costituzionali, tale da assicurare, nel tempo, il prevalere delle idee e delle risorse umane più idonee alla soluzione dei problemi della società e comunque capace di garantire al popolo di procedere al ricambio, per via democratica e pacifica, dei gruppi dirigenti sia dei partiti che dello Stato.
Uno sguardo anche molto rapido alla situazione della politica italiana dall’entrata in vigore della Costituzione ci dice che, la “democrazia reale” – la “Costituzione materiale” come dicono i giuristi – è stata assai poco coerente col modello sopra descritto – dettato dalla Costituzione formale – e ciò ha comportato un grave deterioramento dei rapporti fra cittadini (popolo) e istituzioni pubbliche.
È facile comprendere infatti che se i partiti non adottano il metodo democratico nella propria organizzazione interna diventano “organizzazioni oligarchiche”.
Conseguentemente “l’anello” che deve legare la sovranità popolare alla democrazia dei partiti e la democrazia dei partiti alla democrazia delle istituzioni pubbliche non regge più.
La carenza di democrazia all’interno dei partiti diventa inevitabilmente carenza di democrazia nelle pubbliche istituzioni.
I gruppi dirigenti di qualsiasi partito, come è noto, tendono a conservare la propria posizione direttiva.
A questo scopo adottano, una prassi organizzativa che consente loro: da un lato di controllare l’accesso al partito accogliendovi prevalentemente persone di loro gradimento; dall’altro di procedere alla formazione delle cariche direttive col metodo della cooptazione (aggirando in vario modo le norme statutarie che garantiscono libere elezioni interne).
Tale prassi può realizzarsi senza alcun problema per il gruppo dirigente di qualsiasi partito per il semplice motivo che, di fatto, sono gli stessi membri del gruppo dirigente ad esercitare, le funzioni di “controllo” del rispetto dello statuto e delle norme organizzative interne.
In sintesi, questa prassi consente ai gruppi dirigenti dei partiti di decidere tutte le scelte del partito a loro esclusiva discrezione, svincolati da qualsiasi controllo da parte degli iscritti (e ovviamente degli elettori non iscritti) e di instaurare dunque, all’interno del partito, un regime oligarchico.
Regime che viene immediatamente trasmesso alle Pubbliche istituzioni: dal momento che, in definitiva, i membri dei gruppi dirigenti dei partiti scelgono i candidati, e quindi gli eletti, alle cariche pubbliche (scelgono in primo luogo se stessi e successivamente uomini di loro fiducia).
In sintesi, a seguito di questa prassi, i dirigenti dei partiti (ovviamente in primo luogo dei partiti che ottengono la maggioranza dei consensi elettorali) diventano i veri, e praticamente gli unici, detentori della “sovranità popolare”.
La prassi sopra descritta, che si è andata affermando in forma sempre più marcata col passare dei decenni, è stata chiamata, con un termine molto appropriato, “partitocrazia”.
Non è questa la sede per un’indagine storica sui guasti prodotti alla vita politica e sociale in genere da questo fenomeno patologico della democrazia.
Resta il fatto che oggi “c’è voglia di far fuori la politica intera, c’è disprezzo per la “casta”, i suoi privilegi, il suo attaccamento alle poltrone, l’incapacità di ridurre costi, numeri, personale. È un disprezzo sacrosanto, ma rischia di sfociare in un rifiuto della politica e della democrazia. E dopo cosa c’è, chi viene dopo i politici? I tecnici, i professori, i colonnelli? E perché dovrebbero essere migliori dei precedenti, più disinteressati e più capaci di capire gli interessi generali e non solo quelli del loro settore di competenza, di provenienza e di dipendenza?
Qualcuno dei politici pensa di sopravvivere sulle spalle dei tecnici.
Ma se oggi c’è un rischio di involuzione» democratica, come si ripete spesso a sproposito, se c’è il rischio di una deriva oligarchica, è il rischio della tecnocrazia senza democrazia. I governi commissariati dalle banche, l’alta finanza, i circoli internazionali, le agenzie di rating, la Goldman Sachs: sono loro a decidere e a menare le danze. È un pericolo da non sottovalutare”.
Sull’antitesi tra politica e antipolitica si riflette molto, ormai da circa vent’anni.
L’argomento è stato trattato ai tempi di “Mani pulite” e torna attuale nel tempo presente – scrive Paolo Marini -, quando le cronache ci riportano quotidianamente non i fatti di una politica impegnata al servizio del bene comune, quanto i misfatti di una politica impegolata nel malaffare e costantemente studiata a coprirlo con insopportabile ipocrisia: una metastasi di cui è solo intuibile, al di là di ciò che emerge, la reale portata e diffusione.
Per le prossime elezioni amministrative si annuncia un moltiplicarsi di formazioni e simboli nuovi dovuto alla crisi degli schieramenti tradizionali. La politica moderna ha come dimensione appropriata non la città, ma lo stato. La differenza di scala comporta anche un salto di qualità. Ma può accadere anche che i cittadini per entusiasmo o disperazione si rimbocchino le maniche e si mobilitino.
La politica moderna ha come dimensione più appropriata non la città ma lo Stato; non il libero Comune ma l’intera società civile nella sua vastità e nelle sue interconnessioni.
Condividendo un’analisi di Carlo Galli, è evidente che “lo spazio cittadino è uno spazio diverso da quello statale, nazionale; la differenza di scala comporta una differente qualità della politica, che nella città deve confrontarsi con problemi locali, e deve promuovere uno sviluppo e una qualità della vita non necessariamente omogenei a quelli della nazione intera.
Oggi, nel tempo della politica inefficace e delegittimata, le liste civiche, che potrebbero essere le protagoniste delle prossime elezioni amministrative, sono certamente il segnale della disaffezione fra gli italiani e la politica dei partiti; ma, accanto a una componente qualunquistica e antipolitica – che fa parte molto più del problema che non della soluzione –, accanto a velleitarie chiusure localistiche, quasi che la città potesse immunizzare dal mondo, accanto al rischio di frammentazione del tessuto nazionale, acquistano spesso anche il significato politico di una rivendicazione di autogoverno; come se, insomma, i cittadini presi dall’entusiasmo, o dalla disperazione, fossero spinti al volontariato civico, a rimboccarsi le maniche dall’urgenza di far fronte al degrado delle città e al crollo della qualità della vita.
Certo, c’è la possibilità che le liste civiche siano il palcoscenico per capetti carismatici locali, solo il veicolo di spregiudicati arrivismi, oppure non siano altro che operazioni più o meno credibili di camuffamento di ceti dirigenti locali logori e impresentabili; che improbabili candidature siano destinate a scontrarsi con la complessità della politica e a venire manipolate da vecchi marpioni del mestiere. Eppure, oltre che il segno di una crisi dei partiti, le liste civiche sono il segnale che c’è ancora chi vuole invertire il circolo vizioso grazie al quale il globale scarica tutte le contraddizioni sul locale, per fare della dimensione concreta dei territori il punto d’appoggio per riqualificare il rapporto col mondo vasto e terribile. Per far rinascere la politica da dove è nata: dalla città”.
“Gli attuali partiti italiani? Non sanno più cosa sia la politica – sostiene Galli – Quello che sta infatti apparendo in tutta evidenza all’opinione pubblica non è tanto il fatto che i partiti siano portatori di corruzione – questo è già successo in passato e succede anche altrove nel mondo – ma il fatto che i partiti non fanno più fare e proporre “politica” e non se ne accorgono nemmeno. Tutto quello che sanno fare è difendere, quando ci riescono, i contrapposti interessi frazionari di alcune aliquote di elettori oppure, più spesso, sanno accordarsi tra di loro per qualche riforma di vasta portata, che però non va al di là dell’effetto-annuncio».
Sullo stesso tono anche un recente editoriale di Angelo Panebianco e che cerca di spiegare l’ondata di popolarità degli umori antipolitici. La politica contro cui ci si scaglia nella maggior parte dei casi non è la vera “politica” ma la politica degenerata in partitocrazia.
“I partiti, infatti, nell’Italia del secondo dopoguerra hanno avuto per decenni «un ruolo assorbente, totalizzante, in grado di dominare o controllare qualunque istanza si affacciasse alla vita pubblica: la si chiamasse “Repubblica dei partiti” (nella versione benevola) o “partitocrazia” (in quella malevola) la democrazia italiana si è caratterizzata per decenni come un luogo nel quale i partiti erano tutto e le istituzioni erano niente». I partiti erano diventati, e in buona parte continuano a essere, altro da ciò che è la loro vocazione originaria: far politica. E l’attuale fase di popolarità dell’antipolitica può essere contenuta solo se i partiti accettano di essere altro da ciò che sono stati per troppo tempo, accettando di essere, come sono nelle democrazie meglio funzionanti, organizzazioni finalizzate alla elaborazione di sintesi e soluzioni per le questioni del nostro tempo, alla conseguente raccolta del consenso popolare e alla fornitura di personale autorevole e qualificato per le cariche elettive o di governo, senza più la pretesa di dominare le istituzioni”.
Bisogna avere consapevolezza che, proprio in questa fase in cui si registra la evidente difficoltà della politica a svolgere il suo ruolo di interpretare e tradurre in azioni amministrative e di governo i bisogni della gente, occorre ripartire dai territori e dalle amministrazioni locali, quali sedi storiche e naturali di esercizio della democrazia partecipata, evitando il ritorno al centralismo statale.
“La considerazione importante e urgente che ne deriva è di nuovo e sempre la stessa: per fare una politica ‘nuova’, non esistono uomini nuovi e perfetti, occorrono semplicemente regole inedite, almeno per il nostro Paese, che circoscrivano in modo rigoroso le funzioni pubbliche e la libertà della politica, nel segno dell’autonomia, della rappresentanza e della responsabilità”.




















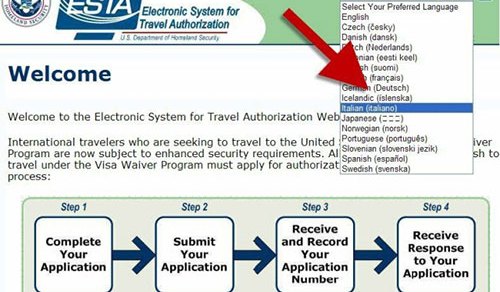
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento