Sicuramente entrambi: tutto, purchè se ne parli! Ecco il vero imperativo categorico. La nuova campagna pubblicitaria promossa da Benetton – UnHate – ha un nobile obiettivo: contrastare la cultura dell’odio, promuovendo la vicinanza tra popoli, fedi e culture.
Ma non sempre il fine giustifica i mezzi.
Analizzando la questione sotto un profilo antropologico, scopriamo che anticamente il bacio sulla bocca era essenzialmente un simbolo di comunione fraterna, anche fra persone dello stesso sesso.
Nella Firenze del Trecento, come narra Dino Compagni nella “Cronica delle cose occorrenti ne’ tempi suoi”, la pace tra fazioni diverse era suggellata da un bacio sulla bocca tra i rispettivi capi.
Nell’era del comunismo baciarsi era considerato un segno di solidarietà. Il bacio tra Honecker (ex presidente della Germania orientale) e Breznev (ex presidente dell’U.R.S.S) nel 1979 è passato alla storia. Ancora oggi “The Mortal Kiss” di Dimitrji Vrubel appare su quel che resta del Muro di Berlino, nella East Side Gallery, ex Berlino est.
Insomma, i precedenti non mancano: forse anche per questo motivo, l’originalità degli artisti che hanno firmato la campagna pubblicitaria poteva partorire altre idee.
Sicuramente surreale è la situazione che nei manifesti pubblicitari vede rappresentati i capi di governo di alcuni stati, notoriamente rivali: il presidente U.S.A. Obama, ora con il presidente venezuelano Chavez, ora con il presidente cinese Hu Jintao; il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, e il premier israeliano Benyamin Netanyahu; il leader supremo della Corea del nord, Kim Jong-il e quello della Corea del sud, Lee Myung-bak, la tedesca Angela Merkel con il francese Sarkozy e, dulcis in fundo, il Papa Benedetto XVI con l’Imam della moschea sunnita del Cairo.
I baci ritratti nei fotomontaggi non saranno sicuramente romantici come il Bacio immortalato da Francesco Hayez o sensuali come quello, non meno celebre, di Gustav Klimt, ma rappresentano un chiaro esempio di arte contemporanea.
Non sempre l’arte è un fine per se stessa, anzi, essa deve contribuire allo sviluppo della coscienza umana e al miglioramento dell’organizzazione sociale. Ma in questo caso, l’arte è stata trasformata in un mezzo per il raggiungimento di un altro fine – la pubblicità del marchio – ad essa estraneo, così svilendo la dignità dell’opera stessa.
Cosa succede, quindi, sotto il profilo giuridico, quando in pubblicità si utilizza l’immagine altrui, oltretutto a fini commerciali, se costui non dà la sua autorizzazione?
L’art. 96 della legge sul Diritto d’autore stabilisce che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”, mentre l’art. 97 chiarisce che “Non occorre il consenso di una persona ritratta quando la riproduzione di un’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta”.
Ricordiamoci sempre che la pubblicità non è manifestazione del pensiero ma attività economica. Quindi, sebbene la qualità artistica dei fotomontaggi possa escludere il possibile ravvisarsi degli estremi della volgarità e dell’indecenza, nel suo complesso l’opera non può, in ogni caso, essere tutelata dall’art. 21 della nostra Costituzione (norma fondamento della libertà di manifestazione del pensiero) in quanto gli scatti riprodotti sono alla base di una campagna pubblicitaria che li fa ricadere sotto l’art. 41 (libertà di iniziativa economica).
Quindi, “non tutto ciò che è lecito in sede di manifestazione del pensiero lo è in pubblicità”: così si espresso il Giurì dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria nella pronuncia 1988/74/3.
Poco importa, poi, che i soggetti rappresentati siano personaggi noti a livello internazionale.
Nel nostro ordinamento, infatti, l’art. 10 del Codice civile tutela l’abuso dell’immagine altrui prescrivendo che “Qualora l’immagine di una persona .. sia stata pubblicata fuori dei casi in cui … la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Più che violazione del diritto alla reputazione o all’onore, infatti, vi è indubbiamente una lesione alla identità personale dei personaggi rappresentati, lesione che sussiste anche per fatti che non sono di per se disdicevoli e non solo falsi. Inoltre, nel caso di violazioni come quelle in oggetto, non si può non tener conto anche della qualità del soggetto offeso, essendo salvaguardabile l’interesse a vedere rispettato nei rapporti esterni, al di là di ogni risvolto offensivo o diffamatorio, ciò che ciascun individuo è e fa dal punto di vista politico, sociale, ideologico e religioso.
Il pensiero, dunque, non può essere inibito ma la pubblicità si.
Già in passato il Giurì ha avuto modo di chiarire che “Contrasta con l’art.1 (“Lealtà della comunicazione commerciale”) del Codice di autodisciplina pubblicitaria il messaggio che rappresenti le atrocità della guerra non già al fine di promuovere valori etici idonei a contrastare tale realtà, ma unicamente con l’intento di produrre un impatto emotivo che concorra a determinare l’effetto di memorizzazione del marchio” (1994/27/6).
Credo che tale pronuncia possa trovare applicazione anche nel caso della campagna pubblicitaria UnHate di Benetton atteso che più recentemente con ingiunzione n.103 del 22.09.2010 e con ingiunzione n.125 del 27.10.2010 il Comitato di Controllo I.A.P ha rilevato – sempre nei confronti dello stessa azienda – “la gratuità della rappresentazione, per niente giustificata da quanto si intende pubblicizzare, che si risolve in un forte impatto emotivo al solo fine di favorire la memorizzazione del marchio e promuovere l’acquisto del prodotto”.
Nulla vieta a un’azienda di diventare portatrice di messaggi sociali: ma dove collocare il limes fra marketing pubblicitario e strumentalizzazione del messaggio sociale all’interno di una campagna pubblicitaria che, per definizione, ha in ogni caso un fine commerciale?
A voi, miei cari lettori, l’ardua sentenza!




















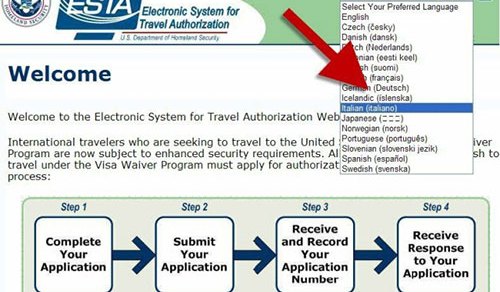
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento