Tizio viene condannato in contumacia all’ergastolo; le notifiche sono state regolarmente effettuate presso il domiciliatario che però non ha comunicato al proprio assistito la sentenza di condanna; l’impugnazione avverso la sentenza di condanna non è stata presentata, né dal difensore che per ragioni varie, ha dimenticato di impugnare; né dall’imputato che, come detto, non è stato informato dal domiciliatario del deposito della sentenza di condanna; la sentenza, non essendo stata impugnata nei termini previsti dalla legge, è divenuta, quindi, definitiva, nonostante l’imputato disponga della prova d’alibi che avrebbe potuto far valere in appello.
Immaginiamo una variante dell’esempio: Tizio viene condannato all’ergastolo in sede di appello, ma riesce ad avere la prova inconfutabile e documentale dell’alibi, solo dopo la condanna, ma prima della presentazione del ricorso per cassazione.
Nonostante l’indubbia differenza tra i due casi (nel primo la sentenza di condanna è divenuta definitiva a prescindere della prova d’alibi; nel secondo, la prova d’alibi è sopraggiunta in un momento nel quale la sentenza di condanna non è ancora divenuta definitiva) la legge processuale non prevede soluzioni differenziate sul piano pratico.
Infatti, tenuto conto che, per quanto riguarda la seconda ipotesi, il ricorso per cassazione diretto all’acquisizione della prova d’alibi sopraggiunta dopo il giudizio di appello sarebbe destinato alla declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di cassazione, che, in quanto giudice di legittimità, non si occupa dell’acquisizione di una prova sopravvenuta, in entrambe le situazioni immaginate, l’imputato condannato, sebbene innocente, deve comunque subire l’esecuzione della condanna e quindi il carcere, a partire dal momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile secondo la legge processuale.
Abbiamo quindi un dato inconfutabile: la nostra legge processuale permette la condanna definitiva dell’innocente, persino quando sia già nota l’innocenza dell’imputato perché per ragioni formali, di mero carattere processuale, la prova sopravvenuta dell’innocenza non può più arrestare il percorso ineluttabile dell’esecuzione della sentenza di condanna, già divenuta, definitiva o comunque, insindacabile sotto il profilo del merito.
Dunque, la legge processuale che dovrebbe contenere tutte le possibili garanzie a tutela dell’imputato innocente, in realtà, produce il risultato, opposto, dell’esecuzione della condanna nonostante l’innocenza dell’imputato.
Fortunatamente, nel nostro sistema non esiste la pena di morte; ma certamente non è da poco l’applicazione del trattamento carcerario, magari con i rigori dell’isolamento, nei confronti dell’innocente.
Prima di discutere sui possibili rimedi rispetto a simili aberranti situazioni, è necessario soffermarsi su un altro paradosso giuridico.
Ed infatti, l’inquietante scenario evoca il concetto dell’ingiustizia, della sentenza ingiusta, dell’esecuzione ingiusta; si pensi, tornando al macabro riferimento alla pena di morte, ad un’esecuzione della pena capitale nei confronti dell’innocente: è questo il massimo esempio di ingiustizia giudiziaria.
Eppure, in simili casi, l’ordinamento giuridico processuale fornisce la risposta opposta e cioè che la sentenza è “giusta” e che l’esecuzione della sentenza definitiva è “giusta”.
Occorre dunque comprendere come sia possibile un fatto del genere, un tale eclatante ribaltamento di significati e di valori.
Partiamo dalla norma costituzionale del “giusto processo” e cioè dall’art. 111 comma 1 della Costituzione, secondo cui “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”.
Come si vede, in questa previsione normativa è contenuta l’equazione, fondamentale e fondante dell’intero sistema processuale, tra “legge” e “giustizia”: l’osservanza della legge automaticamente e necessariamente produce la giustizia.
Ne consegue, a livello processuale, che quando il processo si sia svolto nel rispetto della legge, la sentenza definitiva che lo conclude è necessariamente “giusta”.
Dunque, non c’è giurisdizione senza il “giusto processo” e d’altra parte, il “giusto processo” è l’unica metodologia consentita per l’attuazione della giurisdizione.
Questa prospettiva ha evidentemente una natura formale, direttamente derivata dal principio di legalità che esprime la forza autoritativa della legge che si impone in quanto tale, indipendentemente dal suo contento sostanziale di giustizia.
Ciò dunque significa che la legge, valida perché formalmente corretta, produce i suoi effetti anche se è sbagliata o ingiusta o persino contraria alle intenzioni del legislatore: dura lex sed lex.
Questo principio ha la sua traduzione processuale nel “giudicato” che sancisce la definitività della sentenza irrevocabile quale presupposto dell’ineluttabilità dell’esecuzione.
Insomma, l’accertamento giurisdizionale della colpevolezza dell’imputato nel rispetto delle regole processuali previste dalla legge, genera una sentenza “giusta” la cui esecuzione è doverosa in quanto anch’essa “giusta”.
Ecco il paradosso: si esegue una sentenza perché formalmente giusta anche se l’imputato è innocente.
Il conflitto di valori non potrebbe essere più evidente e clamoroso (ritorna ancora una volta il riferimento alla massima ingiustizia sostanziale dell’esecuzione della pena capitale nei confronti dell’innocente, per di più ammantata dell’ipocrita patina della “giustizia” legale).
Dunque, una sentenza irrevocabile, passata in giudicato, si esegue anche se è “ingiusta” o sbagliata o persino se emessa in conseguenza di un illecito.
Ecco allora il punto: la legge processuale dovrebbe garantire l’innocenza, ma può divenire strumento di soppressione dell’innocenza.
Questa contraddizione in termini è superata nel mondo artificiale del diritto legale, lo jus positum che si autodichiara “giusto” nel momento in cui è osservato; dunque, il processo è “giusto” se rispetta il diritto, anche se, poi, di fatto, il risultato (condanna di un innocente) è “ingiusto”.
Tuttavia, l’esigenza di giustizia “sostanziale” non è (per fortuna) sopprimibile in senso assoluto, tanto che lo stesso diritto formale non può non tenerne conto.
Infatti, lo spettro dell’errore giudiziario, aleggiando su ogni processo e costituendo l’incubo permanente di ogni comunità, richiede idonei rimedi di giustizia.
Lo stesso diritto formale prevede quindi una serie di strumenti giuridici, diretti all’attuazione della giustizia sostanziale, quando, nonostante la formazione del giudicato formale, espressione della giustizia legale, siano comunque emersi elementi che dimostrino “ingiusta” la condanna pronunciata e divenuta definitiva.
Siamo ancora una volta di fronte all’ennesimo paradosso: il diritto formale formalizza la giustizia e costruisce la nozione di giusto processo in senso formale; ma poi, rendendosi conto che la giustizia formale può provocare anche un’ingiustizia sostanziale, allora prevede una serie di rimedi che, però, nel momento stesso in cui sono riconosciuti e previsti, e quindi “formalizzati”, si sganciano dalle esigenze sostanziali che pure dovrebbero tutelare.
Cerchiamo di affrontare in modo ordinato i vari problemi e nei limiti ristretti del presente lavoro che intende soltanto offrire stimoli di riflessione su un tema, oggetto in questo periodo di dibattiti e roventi polemiche.
Infatti, tenuto anche conto del trend normativo sempre più volto all’inasprimento degli effetti penali delle condanne definitive (si pensi, ad esempio, alla c.d. legge Severino) il tema della condanna ingiusta e dell’errore giudiziario, appare sempre più drammatico e in grado di condizionare gli eventi anche politici del Paese.
Innanzitutto, va precisato che nel nostro sistema processuale sono previsti i seguenti rimedi, post rem judicatam, tutti esperibili secondo presupposti, condizioni e regole espressamente previsti:
– ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p.;
– revisione ex artt. 630 ss. c.p.p.;
– procedimento di esecuzione ex artt. 666 ss. c.p.p.
In linea generale e senza avere la pretesa dell’esaustività, si può dire che nel loro complesso i sopra indicati strumenti processuali prendono in considerazione l’errore giudiziario o determinato da vizi del procedimento da cui è scaturita la sentenza definitiva oppure manifestatosi per effetto di elementi sopravvenuti alla luce dei quali la condanna divenuta definitiva appare superata.
Sotto il primo aspetto, vengono in considerazione il ricorso straordinario per cassazione ex art. 625 bis c.p.p. e le situazioni previste negli artt. 667, 668, 669, 670 c.p.p., quali ipotesi di procedimento di esecuzione.
Nel caso del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., sono previsti come casi di ricorso l’”errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla cassazione”.
Con riferimento alle altre situazioni idonee ad instaurare un procedimento di esecuzione, vengono in considerazione: il dubbio sull’identità fisica della persona nei cui confronti si esegue o deve eseguirsi la sentenza (art. 667 c.p.p.); l’errore di nome circa la persona condannata (art. 668 c.p.p.); la pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona (art. 669 c.p.p.); le questioni di invalidità del titolo esecutivo che si è formato sulla base di un giudicato apparente (art. 670 c.p.p.).
Per quanto riguarda invece la sopravvenienza di elementi che rendono non più “giusta” la condanna definitiva, possono essere considerati la revisione ex art. 630 c.p.p. e in sede di procedimento di esecuzione, l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto ex art. 672 c.p.p. e la revoca della sentenza per abolizione del reato ex art. 673 c.p.p.
La casistica è molto variegata e come detto, riguarda tanto l’aspetto dei vizi della procedura che ha portato alla condanna definitiva, quanto l’aspetto del superamento della condanna per effetto di elementi che la rendono ormai sostanzialmente “ingiusta”.
Questo stato del nostro diritto positivo determina due diversi ordini di riflessioni.
Sotto un aspetto rigorosamente giuridico e formale (principio di legalità) si può semplicemente osservare che nel nostro sistema ordinamentale se si vuole contestare un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo, non possono esperirsi che i rimedi previsti dalla legge. Immaginare azioni diverse da quelle espressamente previste significa evocare azioni di violazione del principio di legalità che è e resta uno dei pilastri del nostro ordinamento costituzionale.
Sotto un diverso aspetto, di riflessione metagiuridica, si può osservare, invece, che l’aspirazione alla giustizia sostanziale è talmente importante e insopprimibile che lo stesso legislatore, come si è visto, non ha potuto fare a meno di riconoscerla prevedendo, appunto, gli strumenti sopra indicati diretti al superamento del giudicato.
E allora, in questa prospettiva viene inevitabilmente in considerazione la palese insufficienza degli strumenti previsti.
Basterebbe pensare, per quanto riguarda il ricorso straordinario per Cassazione, che, ad eccetto dei casi dell’errore materiale e di fatto, sono esclusi tutti gli altri tipi di errori che la Cassazione potrebbe commettere (e può commettere e purtroppo commette) nel pronunciare provvedimenti inoppugnabili da cui deriva l’esecuzione della condanna nei confronti dell’imputato.
Così, sono esclusi dalla revisione o dalla possibilità di proporre procedimenti di esecuzione i vizi anche gravi di violazione della legge processuale o sostanziale avvenuti nel corso del processo conclusosi con la sentenza irrevocabile. Si dice, infatti, con una formula stereotipata e antiquata che “il giudicato copre il dedotto e il deducibile”.
Come, ancora, per quanto riguarda le situazioni sopravvenute, sono escluse dai rimedi possibili, tutte quelle sopravvenienze non soltanto di fatto, ma anche di diritto (basterebbe, ad esempio pensare ad un nuovo orientamento interpretativo delle Sezioni Unite della Cassazione) che non sono espressamente previste dalla legge processuale.
Possono allora immaginarsi (e purtroppo verificarsi) casi di esecuzioni “irrimediabili” nei confronti di imputati innocenti.
La domanda, drammatica, è allora se bisogna dunque rassegnarsi al rischio dell’ingiustizia, come se questa fosse una disgrazia inevitabile che colpisce al pari di una malattia o una calamità naturale, oppure se, piuttosto, non si debba ragionare diversamente e affermare l’esigenza della giustizia sostanziale, come massima e sacra aspirazione umana, insopprimibile e non “trattabile”.
E allora se è vero che non possono esistere ostacoli al perseguimento della giustizia, per chiunque e in ogni tempo, ne consegue che occorre profondamente rimeditare la nozione tradizionale e di matrice inquisitoria del giudicato, concepito come verità immutabile e marchio perenne di infamia a carico del condannato, mai più riabilitabile, solo perché impossibilitato da preclusioni formalistiche ad esercitare l’insopprimibile diritto all’affermazione della propria innocenza.
Il cammino è difficile ma possibile.




















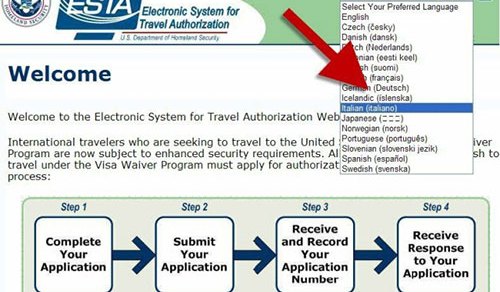
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento